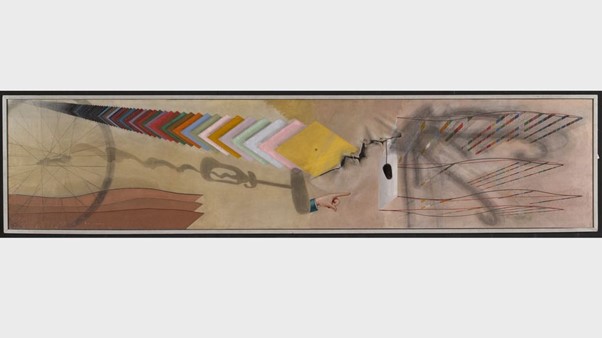Guglielmo Ferroni rivisita la tendenza molieriana di rarefazione della trama di commedie, come Il Misantropo, in una pièce in cui verità e scherzo condividono labili confini, nell’ottica del corso di Letterature comparate B, Verità e coscienza. Narrativa, poesia, teatro (Prof.ssa Chiara Lombardi).
“In questa breve pièce ho cercato di colorare di un tono teso e angosciante, attraverso un espediente semplice, una situazione frivola e priva di interesse e di profondità psicologica, facendo girare attorno al protagonista una schiera di maschere insipide e quasi irreali”.
*
Personaggi (in ordine di apparizione):
Una pecora in tassidermia
Elettra, cameriera e governante
Panfilo, giovane
Elvira, amante di Panfilo
Ettore, giovane, amico di Panfilo
Mercede, madre di Panfilo
Il Padrone, padre di Panfilo
Padre Evaristo, prete
Un cuoco
Interno di un salotto borghese parigino. Costumi e ambientazione in stile inizio Ottocento. Al centro della scena, un tavolo apparecchiato solo in parte. Dal soffitto pende, sopra il centro del tavolo, una pecora in tassidermia, grazie ad una corda che la tiene legata per una zampa posteriore, di modo che l’animale è in verticale e con il muso rivolto verso il pavimento; è libera di oscillare, ed è sospesa a circa un metro dal tavolo. Gli attori devono dare l’impressione di non accorgersi della presenza della pecora, né devono esserne turbati nel modo di recitare e negli spostamenti, salvo differenti indicazioni.

Sipario abbassato; inizia a suonare il I movimento della Sinfonia numero venticinque (K183) di Mozart. Il sipario si alza lentamente e due faretti posti al livello della scena, uno a destra e uno a sinistra, iniziano a lampeggiare ritmicamente. Dopo quaranta secondi o poco più si accendono le luci di scena e illuminano il palco. Dopo ancora qualche secondo, entra Elettra da destra, con in mano una pila di piatti; la musica continua ma a volume ridotto.
ELETTRA: Forza, non c’è un momento da perdere; il campanile ha da poco dato il suo rintocco, il sole schiarisce tutti gli angoli della stanza e il Padrone starà ormai rientrando… piatti, piatti, e i bicchieri, oh quante cose! C’è da sperare solo che quel ragazzaccio del cuoco non sia in ritardo nel preparare le pietanze, altrimenti chi lo sente, il Padrone? Io l’ho detto, fin dal primo momento, l’ho detto, io, che il ragazzo era un buono-a-nulla, ma chi la ascolta, Elettra? Ma io blatero, mentre il tempo scorre, e quanto scorre!
(La musica cresce di volume. Elettra inizia a mettere i piatti in tavola e ad apparecchiare con attenzione, mentre mormora tra sé e sé parole che non si sentono, e si muove veloce ma aggraziata; nel mentre, da sinistra entra, correndo delicatamente, Elvira, seguita da Panfilo. I due si rincorrono per qualche secondo senza parlare, solo ridacchiando ogni tanto. La musica si abbassa di volume e va a sfumare).
PANFILO: Elvira, smettila di farti rincorrere, aspettami! Ah, quant’è difficile il lavoro dell’amante, sottostare al padre e alla madre e perfino rincorrere l’amata come a una battuta di caccia… (Prende il braccio di Elvira, che si divincola ridendo e continua a farsi inseguire per gioco). Basta, rondine impazzita, fermati, fermati e fammi guardare quegli occhi che sembran mandarini… (Elvira esce da destra, Panfilo si abbandona con un sospiro su un divano che è in primo piano, sulla destra). Elettra, quanta grazia, quanta allegria oggi! Che quel nuovo cuoco ti abbia messo qualcosa di diverso dal solito, nel caffè?
ELETTRA (ironica): Quel cuoco non l’ha fatto e non me ne rammarico, signor Panfilo, visto che, come fin dall’inizio Elettra vi aveva fatto presente, egli combina solo guai. Non sono allegra, ma in ritardo! Piuttosto voi, la volete smettere di correre dietro a quella ragazza? Sono giorni che va avanti, e nel vostro viavai mi scombinate tutti i mobili e mi sporcate i pavimenti e…
PANFILO: Suvvia, non vi si può fare un appunto che subito vi mettete a punzecchiare!
ELETTRA: E sia, ma vedete di mettervi in ordine prima che il Padrone arrivi; sapete com’è quando…
PANFILO (stupito, guardando la pecora): E quella? Da dove spunta fuori?
(Pausa)

ELETTRA: Non capisco, signore.
PANFILO: Ma come non capite, Elettra! (Si alza di scatto e si muove verso il tavolo) Non state a prendermi in giro, o a far finta di nulla.
ELETTRA (verso il pubblico): Puah, prenderlo in giro… Davvero, signor Panfilo, io non capisco a cosa stiate facendo riferimento, e per di più sono troppo occupata per star dietro alle vostre sciocchezze.
PANFILO (indicando la pecora): Sciocchezze? E quella vi pare una sciocchezza?
(Elettra segue con lo sguardo la direzione verso cui il suo dito punta, guarda verso la pecora, poi guarda il pubblico, poi Panfilo)
ELETTRA: Lei sragiona e indica il nulla, signore. (Pausa) “A vous dire le vrai, les amants sont bien fous!”. Ora, se permettete, vado a prendere le posate per il pranzo… (Si allontana lentamente, guarda ancora una volta il giovane stranita e poi esce da destra; Panfilo, confuso, la guarda uscire e poi torna a guardare la pecora).
(Pausa)
PANFILO: Che sia… per caso… ma no, Panfilo, cosa vai a pensare! Chiaramente lo scherzo è ben riuscito. E che scherzo, davvero! Me la immagino per bene Elettra, o vai a sapere chi, girare tutte le botteghe della città per trovare questa… pecora! Certo mi rimane da capire perché, ma per il resto… ah, ma ecco che arriva Ettore.
(Entra Ettore, un giovane amico di Panfilo, ben vestito e baldanzoso)
ETTORE: Buongiorno, Panfilo. Deh, ma che pallido che siete oggi.
PANFILO: Su, Ettore, dimmi la verità, non mi si può gabbare a tal punto.
ETTORE: Non ti seguo.
PANFILO: C’è da dire, l’idea è originale, e mi chiedo cosa abbia spinto Elettra o te o vai a sapere chi a metter tanta cura nella preparazione dello scherzo, ve lo concedo… Ma ora basta e dammi una mano a tirarla giù, che quando arriverà mio padre non voglio che un oggetto di così cattivo gusto penda sopra la sua testa. (Pausa. Ettore guarda Panfilo non capendo) E va bene, stiamo al gioco. (Sospira) Ettore, buongiorno, per caso guardandovi intorno notate qualcosa di strano nella stanza, qualcosa che pende?
(Pausa. Ettore si guarda intorno)
ETTORE: Io davvero non… non capisco… cos’è questa cosa che pende? State parlando del lampadario per caso? Non sapevo lo disprezzaste a tal punto, e l’altro ieri quella giovane ragazza che avete preso con voi da poco è stata così tanto a lustrarlo, pendente per pendente; ma se davvero non lo sopportate…
PANFILO: Ettore! Basta! Ve l’ho detto, siete stati bravi e sebbene tu sia solo il secondo di oggi che sento recitare, perché sono convinto che Elettra o mia madre o… Ma non importa! Sì insomma state tutti facendo un’ottima prova da attori, ma basta, aiutami a tirarla giù o lo farò da solo.
(Pausa. Ettore guarda la stanza senza capire)
ETTORE: Panfilo, io non… Cosa volete tirare giù?
PANFILO (urlando): La pecora, Ettore! Questa maledetta pecora che vedi tu stesso, di fronte a te! PE-CO-RA.
(Pausa)
ETTORE: Amico mio, se state scherzando lo state facendo bene. E anzi, a dirvela tutta mi stavo quasi preoccupando! (Scoppia in una risata; poi si avvicina a Panfilo e gli dà una pacca sulla spalla) Suvvia, ora basta, ero passato per vedere come fosse la vostra salute e per sapere se foste infine giunto a una decisione sul matrimonio con Elvira, ma evidentemente (ridacchiando), evidentemente siete troppo impegnato con le vostre… pecore, o che so io! Beh, sempre meglio avere le pecore per la mente che le corna in testa… (ridendo) Vi saluto, Panfilo, e portate i miei saluti anche a vostro padre, mi è stato detto che sta arrivando; arrivederci a tra poco… (Esce da destra, sempre ridacchiando e ripetendo sotto voce “Le pecore… le pecore…”).
(Panfilo, immobile, guarda Ettore uscire. Pausa. Poi si gira verso il pubblico)
PANFILO: Sono… sono… (pausa) Sono tutti ammattiti, ecco cosa sono! Ma io dico, è mai possibile? Basta, questa scenata deve finire.
(Va verso il tavolo, guarda la pecora. Poi, sale in piedi su una sedia e si accinge a slegare il nodo che la tiene legata per la zampa. Entra Elettra, con le posate in mano)
ELETTRA: Panfilo, ma che state facendo! Su, forza, giù di lì. Sporcate la sedia con i vostri stivali, ma insomma! Che vi prende?
PANFILO: Elettra, devo ammetterlo, vi siete superata! Sì, è venuto veramente bene; è di buona fattura, e questa corda legata stretta stretta, e anche l’odore che emana, tutto davvero ben studiato, ma ora basta, la tiro giù.
ELETTRA: Ah, Panfilo, sempre a scherzare… ma che pallido che siete. Su, venite giù. (Inizia a mettere le posate di fianco a ciascun piatto)
PANFILO (a voce alta): No. Non scendo. Non finché non l’ho tirata giù e non mi raccontate il perché di tutta questa faccenda.
(Pausa)
ELETTRA: Ma cosa, cosa volete tirare giù? Smettetela di far finta di essere impazzito, sapete che su queste cose non si scherza! Ricordo di un mio zio, tempo fa, che…
PANFILO: Basta! Silenzio, taci! Tirerò giù questa pecora e tu la porterai via! Non sarò il padrone, o meglio non ancora, ma non mi si può mancare di rispetto così, anche se solamente per scherzare!
(Pausa. Elettra fissa Panfilo. Silenzio prolungato)
ELETTRA: Cheeeee? Una pecora? (Si mette a ridere) Questa vi è davvero uscita bene, signore! Vi va bene che oggi la giornata è bella e che sono di buon umore, altrimenti… cavolo, mi stavate spaventando! (Ridacchia ancora) Ora basta però, scendete da lì che devo…
(Panfilo salta dalla sedia al tavolo e sbatte il piede con prepotenza su di esso)
PANFILO (urlando): Smettetela! Come potete ancora fingere, schiava! Come osate appendere un animale morto sopra le teste di coloro che vi danno da vivere! Che il diavolo ti prenda, maledetta!
(Mentre urla, entra Mercede da destra. Donna sulla quarantina, vestita elegante)
MERCEDE: Allora, che cos’è tutto questo urlare, cosa accade? (Vede Panfilo in piedi sul tavolo) Figlio mio, che ci fai sul tavolo? Perché sbraiti tanto? E tu, Elettra, non gli dici niente?
(Elettra guarda un po’ impaurita Panfilo, che la sta fissando. Dopo una breve pausa, si sposta indietro e verso Mercede)
ELETTRA: Signora, stavo giusto per chiamarvi; già ho cercato, di farlo ragionare, ma egli per tutta risposta mi ingiuria e mi urla contro, al punto che sono indecisa tra la rabbia o la paura, perché è evidente che sia impazzito.
(Pausa. Mercede si avvicina sospettosa verso Panfilo, ed entrambi si fissano)
MERCEDE (lentamente): Ci guardiamo come fiere sospettose, figlio mio; perché mai?
PANFILO (calmo ma teso al tempo stesso): Non lo so, madre, ditemelo voi, ditemelo proprio voi che tirate in ballo queste metafore e parlate di fiere. Non ditemi, ve ne prego, che anche voi avete accettato di far parte di questo insulso scherzo che mi sta snervando. E non ditemi che voi stessa, padrona di casa, moglie di mio padre, avete accettato che questa carcassa pesasse sulla sua, sulla nostra testa, senza pensare alle conseguenze di un gesto tale!
(Pausa)
MERCEDE: Figlio… (pausa). Quale scherzo, quale carcassa?
PANFILO (urlando): Ci risiamo! Ancora! (Batte il piede sul tavolo come prima) Anche tu, Mercede, madre mia! Do i numeri, divento cieco per la rabbia… Com’è possibile che siate tutti così seri! Così convincenti! E per quale motivo mi arrecate tanto dolore… Ah, ma ecco chi mi salverà! (Indica verso la sinistra) Su, vieni Elvira, e facciamola finita con questa farsa, con questa commedia.
(Entra Elvira con le mani in grembo, a capo un po’ chino, evidentemente intimorita dalle grida di Panfilo)
ELVIRA: Eccomi, Panfilo, ho sentito da sopra tutto questo baccano e… Elettra, Mercede, che vi accade? Vi vedo così turbate… e anche tu, Panfilo, ma cosa…
(Viene interrotta da Panfilo che salta giù dal tavolo e corre verso di lei. Elvira si ritrae un po’ impaurita. Panfilo la raggiunge e le prende le mani)
PANFILO: Elvira, Elvira, io… come posso… (si guarda intorno, guarda la pecora, poi di nuovo Elvira negli occhi) Almeno tu, finiamola. Dillo. Dì ciò che vedi nella stanza, sopra il tavolo, per esattezza, su, basta una singola parola.
(Pausa, Elvira si guarda intorno)
ELVIRA: Panfilo, io non ti seguo.
PANFILO (urlando, e spaventando per questo Elvira): Non è possibile. Non è possibile, dovete spiegarvi, dovete spiegarmi, io non ce la faccio più, Elvira! Smettetela! (Pausa. Poi con tono supplichevole) Elvira, rondine, te ne prego… fatela finita, fate finire tutto. Se è vero che mi amate, se tutte quelle risate e quelle lacrime non sono state finte promesse, dite ciò che vedete. Ditemi che quella pecora è uno scherzo, e che voi ed Elettra siete andate da un… venditore di pecore, o che so io… (Pausa. Elvira tace) Dunque…
ELVIRA: Panfilo, oggi è la prima volta che vi vedo in questo stato. Avete la febbre, delirate? Quale pecora, quale venditore… Elettra, ne sapete qualcosa? Io penso che la stanchezza, magari… Ma non spiegherebbe delle allucinazioni tali, e poi dove sarebbe, questa pecora? Starebbe ruminando liberamente, magari mangiando il tappeto che è lì vicino al tavolo… ah!
(Mentre parla, cresce la rabbia in Panfilo. Alla fine, è sul punto di tirarle uno schiaffo, ha già alzato il braccio per colpirla. Elvira, spaventata, si ritrae; Panfilo rimane qualche secondo fermo con il braccio alzato, poi lo abbassa e china il capo. Pausa. Dopo qualche secondo, sempre a capo chino, si dirige verso il divano e vi ci siede sopra, con la testa tra le mani. Elvira, Elettra e Mercede si avvicinano e iniziano a borbottare parole incomprensibili. Dopo qualche secondo, si sentono le voci di due uomini che discorrono e che si fanno sempre più vicine. Entrano da destra, da dietro al divano, il Padrone e Padre Evaristo, un prete)
PADRONE: Ed è per questo, padre, che decisi di ringraziare in tal modo il curato, sapete…
PADRE EVARISTO: Certo, signore.
PADRONE: D’altronde, mi sarebbe altrimenti sembrato di mancar di rispetto… Ah, buongiorno a tutti, qui riuniti! Mi sembra manchi solo Ettore, ma possiamo già accomodarci a tavola, e perdonatemi se senza preavviso Padre Evaristo si unirà al nostro pranzo, ma si deve discutere di certe cose… Ma che accade, vi vedo turbati! Donne, perché state là in disparte… (pausa, poi nota Panfilo sul divano) E Panfilo, figlio mio, che vi succede? State per caso male?
ELETTRA: Signore, vedete, è già da prima che…
PANFILO (urlando, sempre con la testa tra le mani): Taci! (Pausa, poi rialza la testa e guarda suo padre e padre Evaristo) Buongiorno signori, perdonatemi, è da tutta la mattina che sono perseguitato dal mal di testa.
PADRE EVARISTO: Si vede, figliuolo! Siete così pallido, quasi candido…
PANFILO: Sarà la primavera che giunge, padre, non c’è da preoccuparsi. Ma prego, accomodatevi a tavola, arrivo in un attimo.
(Il Padrone e Padre Evaristo si guardano velocemente, poi guardano le donne. Nel mentre, da sinistra entra Ettore)
PADRONE: Ah, Ettore, aspettavamo solo voi!
ETTORE: Eccomi, buongiorno a tutti, ero giusto uscito per delle commissioni.
PADRONE: Bene, allora direi di sederci, signori.
(Il Padrone, Padre Evaristo, Ettore, Mercede ed Elvira si muovono verso il tavolo, mentre Elettra si affretta a mettere in ordine le sedie, i piatti, i bicchieri, per poi uscire di scena dopo aver lanciato un’ultima occhiata a Panfilo. Panfilo rimane ancora sul divano, nuovamente con la testa tra le mani. I convitati si siedono in modo che tutti i posti sono occupati tranne quello centrale, ossia quello che dà la fronte al pubblico, ed è in linea con la pecora. I convitati iniziano a parlare tra loro sottovoce; le donne in modo preoccupato e guardando Panfilo, gli uomini in modo allegro).
ETTORE: Panfilo, allora, che fate? Vi decidete a venire a sedervi con noi, o ancora pensate allo scherzo di poco prima, con cui mi avete burlato?
PADRONE: A cosa vi riferite, Ettore?
ETTORE: Oh beh, vedete, signore, vostro figlio stamattina mi ha quasi fatto credere che solo lui fosse in grado di vedere, sopra il tavolo, una pecora, come se fosse attaccata al soffitto! Va detto, la creatività non gli manca…
PADRONE: Cosa? Una pecora? (Guarda la pecora per qualche istante, poi Ettore, poi Padre Evaristo, seduti di fianco a lui, e poi si rivolge al pubblico) Che assurdità!
PANFILO (si alza dal divano, guarda il pubblico; tono grave): Che assurdità… Mansueto e pacifico, oggi sopporto le offese… eppure si crea il vuoto, intorno a me, è il fuoco che mi isola nel campo… quella sensazione…
(Si dirige verso il tavolo. Arrivato, guarda la pecora, dando le spalle al pubblico, e le dà una spinta, di modo che essa inizi ad oscillare. Solleva le spalle e va a sedersi al posto che è rimasto libero. Da destra entra un cuoco, portando un vassoio con sopra della carne, che pone al centro del tavolo, sotto il muso della pecora; poi esce)
PADRONE: Signori, mi avvantaggerei della presenza di padre Evaristo per recitare una breve preghiera. Uniamo le mani.
(I convitati uniscono le mani, e chinano il capo, tutti tranne Panfilo, che fissa la pecora)
PADRE EVARISTO (con tono sommesso e monotono): “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis…”
TUTTI, tranne PANFILO: “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem”.
(Si fermano. Silenzio. Panfilo guarda il pubblico)
PANFILO: Occhi come mandarini. (Pausa).
Quella sensazione di
giorni verdi
e acerbi come cachi
e il rumore del
crollo delle certezze
arbusti a sud, fichi spaccati
e il prurito
perché abbiamo sudato.
E pace sia.
Riprende, a volume basso, la sinfonia di Mozart dell’inizio. Le luci vanno a sfumare, fino a spegnersi. Dopo che si sono spente del tutto, i due faretti dell’inizio pulsano ritmicamente per qualche secondo. La musica finisce, sipario.