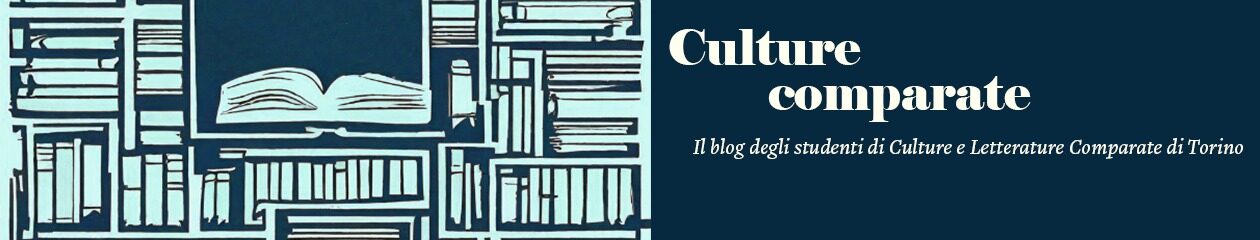di Alessandra Aprea
In questa ‘lettura’, si propone un’esposizione critica dell’ultima opera di Cervantes, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia Septentrional, mettendo in luce l’impiego dell’ ékphrasis da parte dell’autore spagnolo in alcuni snodi fondamentali della storia.
☙
La scrittura e l’immagine abitano da sempre una tensione irrisolta: la prima tenta di dare forma all’invisibile, la seconda di rendere visibile ciò che sfugge alla parola. L’immaginazione umana in questo circolo è di essenziale importanza, come ci viene descritto anche da Calvino in Lezioni americane: attraverso il testo, il lettore costruisce mentalmente scene, volti e ambientazioni, attivando un processo di visualizzazione interiore che varia in intensità a seconda della qualità e della suggestione della scrittura [1]. Questo fenomeno, strettamente legato alla potenza evocativa del linguaggio, mostra come la letteratura sia capace di rendere visibile ciò che di per sé è astratto, trasformando parole in immagini mentali più o meno definite.
Riguardo a ciò che accomuna l’atto di scrivere e quello di dipingere, Cervantes, nella sua ultima opera, sostiene, all’interno di uno dei suoi tipici inserti metadiscorsivi: «La storia, la poesia e la pittura si rispecchiano vicendevolmente e sono così somiglianti che quando stai scrivendo storia, dipingi, e quando stai dipingendo, componi» [2]. In questo passaggio, l’autore spagnolo propone una visione sorprendentemente moderna dell’osmosi tra arte e scrittura e mostra come entrambi i mezzi espressivi condividano un orizzonte di evocazione dell’immagine e creazione di simboli e significati. [3]
Gli autori, sia in prosa che in versi, ricorrono frequentemente a diverse tecniche per modellare e conferire vividezza e spessore alla parola scritta. Tra queste, troviamo, per esempio, la metafora, la sinestesia e la personificazione, che donano al testo un maggior significato e impatto. Un altro strumento di grande rilevanza per gli scopi appena illustrati, e non solo, è l’ékphrasis, definita da Cometa come «la forma più tradizionale di rapporto tra letteratura e arti figurative». [4] Questo lavoro si propone di esplorare proprio l’uso di tale espediente nella letteratura spagnola del Siglo de Oro, con focus particolare sull’ultima grande opera di Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional, pubblicata postuma nel 1617. L’ékphrasis, che intreccia l’immagine visiva con la narrazione, assume un ruolo centrale nell’opera, offrendo spunti di riflessione sia sul piano visivo che metanarrativo. In questa analisi, si prenderà in considerazione in particolar modo la descrizione di un lienzo, fatto realizzare dal protagonista del libro, Periandro-Persiles, e si esaminerà poi l’inserimento delle rappresentazioni pittoriche dell’altra protagonista, Auristela-Sigismunda.
Il Persiles fu un’opera annunciata da Cervantes con largo anticipo e grande trepidanza, sintomo dell’importanza che l’autore le attribuiva. Già nel prologo delle Novelas ejemplares (1613), l’opera era descritta come capace di competere con i più illustri romanzi greci, come le Etiopiche di Eliodoro. Un anno dopo, nel Viaje del Parnaso, l’autore sottolinea le sue grandi aspettative usando l’aggettivo “gran”. Nel 1615, Cervantes ne parla anche nel prologo della seconda parte del Don Quijote e nella dedicatoria delle Ocho comedias y ocho entremeses, annunciando il completamento imminente. Nella dedica al Don Quijote, scrive che l’opera sarebbe stata “o il più cattivo o il migliore libro di intrattenimento in castigliano”, esprimendo fiducia, ma anche consapevolezza del rischio nel confrontarsi con un genere consolidato. Nonostante le alte aspettative, la fortuna critica del Persiles è stata inferiore a quella sperata e soprattutto è stata oscurata dall’immenso successo del Don Quijote, che è stato riconosciuto come il vero capolavoro di Cervantes. L’opera è divisa in quattro libri e narra la storia del principe dell’isola di Thule, Persiles, e della principessa dell’isola di Frislandia, Sigismunda. I due innamorati, fingendosi fratello e sorella, assumono i nomi di Periandro e Auristela e, nel corso del romanzo, seguiamo le loro vicende e gli incontri con personaggi eccentrici, talvolta determinanti per lo sviluppo degli eventi. Il loro viaggio inizia a Thule e si estende attraverso il mare settentrionale nei primi due libri. A partire dal terzo, i protagonisti giungono a Lisbona, segnando l’inizio di una nuova fase del racconto, ora ambientato in terre meridionali. Da lì, il loro percorso prosegue verso Roma, meta dichiarata fin dalle prime pagine del libro. La stesura del Persiles si inserisce in un clima letterario caratterizzato da una forte ripresa del romanzo greco e, come molti altri titoli del periodo, presenta diversi elementi che possono rappresentare punti di contatto con questo modello narrativo. In particolare, è evidente il confronto con Eliodoro, con cui l’opera si pone apertamente in competizione. Tali elementi sono riscontrabili, per esempio, nell’inizio in media res, il gran numero di peripezie, la proliferazione di narrazioni secondarie, travestimenti e ambientazione in “terre esotiche”. È a questo universo letterario che si ispira Cervantes, il quale comunque non resta indifferente alle teorie letterarie del XVI e XVII secolo, cercando di creare un’“opera epica in prosa”. [5] Lo studioso ispanista e cerventista Edward C. Riley riflette in merito alla questione illustrando proprio come Cervantes, seguendo la tradizione di Eliodoro e dei romanzi bizantini, tenta di unire anche la tradizione epica e la narrazione amorosa e d’avventura tipica dei romance cavallereschi. Tuttavia, il Persiles risultò mantenere una struttura molto più rigida e idealizzata, mentre il Don Quijote trasforma l’eredità letteraria del passato attraverso l’ironia e la figura dell’antieroe, con il risultato di occupare lo spazio che l’autore aveva riservato al Persiles, quasi per ironia della sorte. [6] Cervantes, pertanto, raccoglie molto dalle tradizioni del passato, e non si limita solo all’epica e ai romance, tanto che nei suoi scritti e in particolar modo nel Quijote e nel Persiles, due opere che in qualche maniera comunicano sempre tra di loro, risuonano echi dei canoni classici antichi, di Petrarca e del Rinascimento italiano in generale. Nelle sue opere, l’autore riflette frequentemente sull’idea oraziana dell’ut pictura poesis, un topos critico ricorrente in Cervantes. Egli inserisce spesso esempi di contaminazione tra arte visiva e scrittura, rendendo così le sue opere intrise di un forte pittorialismo. È sufficiente pensare all’episodio emblematico dei mulini a vento presente nel Don Quijote, episodio in cui il lettore è portato a immaginare non solo gli oggetti descritti, ma anche la loro trasformazione nella mente di Don Quijote. [7]
Si arriva a questo punto ad esplorare il rapporto tra Cervantes e l’uso dell’ékphrasis, la quale è una vera e propria acquisizione o, meglio, un’integrazione, di un’opera pittorica o sculturea (esistente oppure inventata) all’interno del testo scritto. Questa tecnica, che affonda le sue radici nell’antichità e fu particolarmente diffusa durante il periodo della Seconda Sofistica, consente di evocare, attraverso la scrittura, delle immagini vivide, ponendo l’oggetto direttamente davanti al lettore. In tal modo, la narrazione diventa più complessa e interessante.
Nel Persiles, l’uso dell’ékphrasis e di altre tecniche di visualizzazione non solo arricchisce la narrazione, già ampiamente caratterizzata da “commisture estetiche”, ma alimenta anche un dialogo metadiscorsivo e metanarrativo. L’episodio di Ruperta, per esempio, collocato nei capitoli sedicesimo e diciassettesimo del terzo libro, è presentato attraverso una lunga scena teatrale che trasforma i personaggi principali in spettatori. Questo inserto riflette la “fluidità intergenerica” della scrittura cervantina. [8] Oltre a ciò, sono presenti personaggi strettamente legati al mondo delle arti come Clodio, il “poeta satirico” del re; oppure Rutilio, maestro di danza senese, rappresentante dell’influenza della cultura italiana e la mescolanza di arti performative all’interno del romanzo; o ancora la figura di Feliciana de la Voz, con la sua voce stupenda, è uno degli esempi dell’inserimento della musica e del canto nella narrazione. In aggiunta, anche nel Persiles si possono notare diverse sequenze che posseggono una forte visibilità e, per citarne alcune, si può fare riferimento alla sequenza dell’isola sognata al quindicesimo capitolo del secondo libro oppure alla regata delle barche allegoriche nel capitolo dieci del secondo libro.
Uno degli esempi più significativi di ékphrasis all’interno dell’opera spagnola è quella del lienzo ordinato da Periandro a Lisbona, all’inizio della terza parte del romanzo. I viaggiatori sono appena approdati sulla terra ferma, finalmente il loro girovagare in nave è terminato e da qui in poi potranno proseguire via terra il pellegrinaggio verso Roma. Il loro arrivo a Lisbona viene subito notato e tutti, «da gente plebea a cortigiana», sono meravigliati dalla stravaganza degli abiti che indossa il gruppo di nuovi arrivati e dall’estrema bellezza di alcuni di loro. Nei giorni trascorsi a Lisbona l’insolito gruppo si ritrova nella casa di un pittore famoso, del quale non ci è dato sapere il nome, ed è proprio qui che Periandro commissiona una tela: