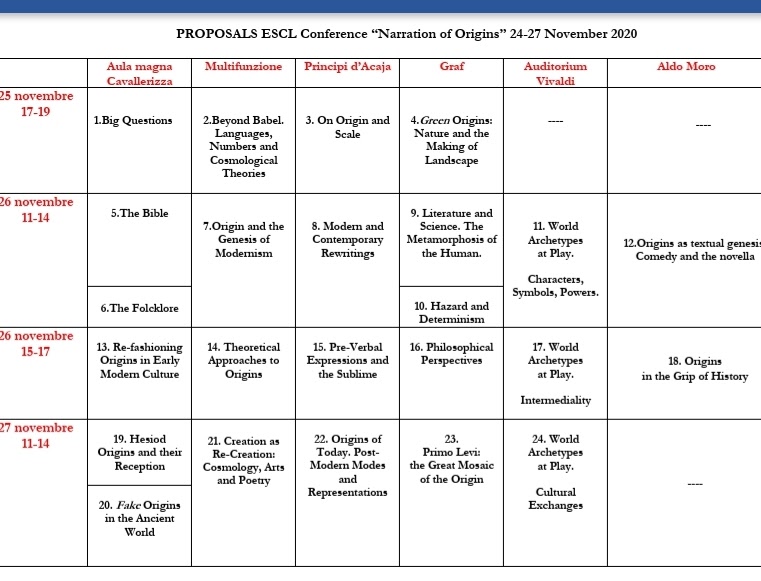Claudio Saleri, laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo alla Cattolica di Brescia, ha frequentato il corso di Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale. È iscritto all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Lombardia e collabora con il Giornale di Brescia. Frequenta il corso di Culture Moderne Comparate presso l’Università degli Studi di Torino.
In questo suo articolo si concentra sul topos di Ercole al bivio nella contemporaneità, passando per la figura amletica di Don Leo, protagonista di “Bruciare tutto” di Walter Siti.
*
La storia della letteratura è costellata da storie di amori impossibili. Le hanno raccontate Omero e Shakespeare, poi ancora Flaubert e Tolstoj; la lista è troppo lunga per essere riportata qui. Esiste poi un altro tipo di rapporti erotici che va oltre a quello dell’amore impossibile, ne supera l’immanenza; è quello in cui Eros e dannazione si intersecano fino a diventare un binomio inscindibile: come non pensare ad Inferno V, ad un amore che trascende le candide parvenze stilnovistiche e si configura come desiderio travolgente e divoratore, che non può che condurre i due inseparabili amanti all’eterna sofferenza. Nel celeberrimo trittico di terzine legato dall’anafora “amore” (Inferno V, vv. 100-108) questa connotazione della passione erotica è evidente, l’amore “al cor gentil ratto s’apprende”, non nasce da una scelta consapevole, “a nullo amato amar perdona”, si impossessa con violenza del “lago del cor” (Inferno I, v. 20),(1) della parte più profonda dell’essere umano, e non l’abbandona più.
Don Leo convive con il desiderio, cerca di resistervi per tutta la vita aggrappandosi alla fede in un Dio che ad un certo punto smetterà di rispondergli, e alla fine anche lui non potrà che rimanere consumato dall’amore per Andrea. Mentalmente, spiritualmente, e corporalmente; nell’ardore delle fiamme distruttrici (e purificatrici?). Walter Siti ha scelto di andare oltre gli amori impossibili per concentrarsi su un tabù, sposo della dannazione per eccellenza, specialmente oggi.(2) Ha scelto di parlare di pedofilia, ha voluto mettere il dito in una piaga ancora sanguinolenta per la Chiesa, che l’ha coperta di una macchia difficile da tergere. Una macchia che ha cominciato a prendere forma all’inizio del ventunesimo secolo, con un’inchiesta avviata dal Boston Globe.Quest’ultima ha segnato soltanto il primo passo di una presa di conoscenza da parte dell’opinione pubblica di un lato oscuro (e ben celato, per la verità) della Chiesa Cattolica, poi dimostratosi un fenomeno diffuso a livello mondiale, insinuatosi nelle molteplici diramazioni dell’istituzione ecclesiastica. Un cancro metastatico al punto da diventare uno dei cavalli di battaglia della propaganda anticlericale, oltre che oggetto di numerosi studi in ambito psicanalitico e non. C’è chi, come il filosofo e sociologo Slavoj Žižek, sostiene che la pedofilia sia iscritta nell’identità stessa della Santa Madre Chiesa. Secondo lui il fenomeno è impresso nel suo funzionamento come istituzione socio-simbolica, il che non riguarderebbe quindi l’inconscio privato degli individui, bensì quello dell’istituzione stessa, nella forma di un ritorno del rimosso sotto forma di perversione, causato dalla transvalutazione valoriale della negazione di ogni pratica sessuale nel corpo dei sacerdoti. Žižek attua un parallelismo con i riti sessualizzati del nonnismo nell’esercito, che proprio come la Chiesa si pronuncia pubblicamente contro i rapporti omoerotici, ma nei fatti ne garantisce la perpetuazione in nome di un accordo sociale non scritto.(3) Un’effettiva condanna di queste pratiche dovrebbe smuovere attivamente la regione sotterranea che le cela, invece vengono brutalmente attaccate e bollate come oscenità esterne all’istituzione.(4) Secondo Žižek è proprio l’atteggiamento difensivo adottato dalla Chiesa che conferma l’appartenenza dei crimini alla sua identità istituzionale: la tendenza a minimizzare e isolare i casi, a liquidare le accuse come scandalismo e propaganda anticattolica, le ritrattazioni condizionali.(5) Le posizioni adottate dai due attuali pontefici, ovvero il papa emerito Benedetto XVI e il successore Francesco, seppur differiscano per qualche sfumatura, sono accomunate da questa tendenza di fondo. Bergoglio scende dal podio e si unisce ai contestatori, invocando l’ira divina sui colpevoli;(6) Ratzinger invece sostiene apertamente la natura alloctona di questo male diffusosi nella Chiesa, stigmatizzandolo come figlio dell’esaltazione della libertà sessuale del Sessantotto, che avrebbe visto la nascita di lobby omosessuali nelle diocesi e nei seminari.(7)
Pierre Dalla Vigna si sofferma sull’interessante tematica dell’iconografia cattolica e della sessualizzazione delle opere d’arte, che ritroviamo a più riprese anche nel romanzo di Siti: don Leo ha una fobia per le immagini sacre che lo ha sempre portato a disprezzare la storia dell’arte, ha paura che i piccoli e paffuti corpi dipinti possano risvegliare i suoi appetiti sessuali:
[…] la sua ignoranza in storia dell’arte dipende dal fatto che temeva di incontrarne il corpo perfino dipinto. (Runge, magnifico ruffiano; Spierincks e il suo sileno nudo tra piccini anch’essi nudi che lo legano con tralci d’edera.)(8)
E ancora:
Leo non aveva anticorpi, per questo le lumeggiature dei putti dagli affreschi della cattedrale, e i residui di cromia sui pomelli delle guance negli altorilievi, furono liberi di germinare indisturbati. La storia dell’arte cominciò a fargli paura: la Camera degli sposi a Mantova da sotto in su, gli amorini con le frecce intorno a Venere Pandemia, una lotta di angioletti nelle pagine del Seicento bolognese. Li rivedeva la notte, a occhi e libri chiusi: i san Giovanni elastici che dimostravano dai tre ai dodici anni, come se il corpo non li avesse ancorati a questa terra.(9)
Dalla Vigna sottolinea il contrasto tra la severa condanna della sessualità al di fuori dall’ambito matrimoniale da parte della Chiesa e l’estrema libertà d’azione concessa agli artisti occidentali nelle rappresentazioni sacre, forse dovuta all’impossibilità di una rappresentazione autentica del divino. L’esempio paradigmatico ce lo offre tutta l’iconografia su san Sebastiano: nonostante sia divenuto martire in età matura, sin dal Quattrocento siamo abituati a vederlo rappresentato come un giovane seminudo legato a un palo, che sprigiona un erotismo inconfessabile.(10) Dopo Botticelli sarà Giovanni Antonio Bazzi ad accentuarne l’aspetto efebico, in Saraceni il santo è semisdraiato in evidente orgasmo, con una freccia all’inguine che arrossa il tessuto che copre la pudenda; ma l’elenco potrebbe continuare: da Perugino a Raffaello, da Rubens a Guido Reni e via dicendo.(11)
Don Leo conosce solo un modo per resistere al desiderio e (quindi) al peccato, ovvero avere fede in Dio, affidarsi a lui e invocarne la pietà e il perdono. Spesso nei suoi pensieri torna alla sua debolezza, alla sua inettitudine: senza un aiuto dall’alto si sente incapace di far fronte alle difficoltà della vita, alle insidie grottesche che spesso questa gli pone dinnanzi. Per ciò, quando Dio smette di rispondergli dall’alto dei cieli, l’unico atto di libertà che può compiere per resistere alla tentazione erotica è quello di sparire definitivamente, annientando la sua volontà, perché il desiderio fa parte di lui e non può reprimerlo, non con le sue forze almeno. Nonostante la suggestiva simbologia connessa all’immagine del fuoco, la morte di Leo ha poco di estetico, è soltanto l’unica alternativa che sente di avere quando capisce di non avere la forza interiore di vivere, quella forza che ha sempre cercato all’esterno e che poi gli viene improvvisamente a mancare. Non ha scelta, è come un treno che non può fermarsi e finisce inevitabilmente col deragliare. È il bandolo della matassa dopo Nietzsche, dopo che “Dio è morto”. Coloro che hanno sempre cercato Dio al di fuori di sé sono rimasti soli, in un universo stupido (e quindi anche crudele). È il buco nel cielo di carta pirandelliano, di cui parla Anselmo Paleari ne “Il fu Mattia Pascal”:
Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.»
«Non saprei» risposi, stringendomi ne le spalle.
«Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo.»
«E perché?»
«Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.»(12)
Al netto della caduta dei “lanternoni”, della secolarizzazione, la sfida dell’Homo postmoderno è quella di trovare dei valori in cui credere in un orizzonte nichilista. Non volgendosi all’indietro, riutilizzando impropriamente i vecchi ideali ormai decostruiti, cercando di rimettere insieme i cocci, le macerie lasciate dalla storia; ma costruendone di “nuovi”, che pur nella loro relatività in quanto figli di un mondo in cui tutto è frammentato, abbiano un che di universale, non quello in cui tutti devono credere, ma quello in cui l’io deve credere.
La personalità di don Leo è un fragile castello di carte tenuto insieme dalla fede. Dopo che il cielo di carta si è bucato, dopo la morte di Dio, non può che arrivare il momento del to be or not to be. L’uomo creato dal Dio cristiano porta con sé l’immagine del suo creatore, sente in sé stesso l’ispirazione al comportamento orientato alla carità. Dio ha deciso di conferirgli la libertà di scegliere se compiersi come sua creatura o meno, allontanando la voce del male.(13) Il dovere permanente della Chiesa è quello di scrutare i segni dei tempi e dei luoghi nella storia che indicano la volontà di Dio. Tutto ha origine nel principio, nella Genesi: Dio sa ciò che è bene e ciò che è male, l’uomo no e gli è proibito di cibarsi del frutto dell’albero della conoscenza. Lo Spirito Santo, terza persona della Trinità e dono tra i doni di Dio, è prima di tutto pneuma heghemonikón, ovvero “spirito che guida”. Il discernimento è la prima operazione dello Spirito nell’essere umano, è un dono che viene dall’alto e che si unisce all’anima del cristiano: come tale va quindi desiderato e invocato. Non è una virtù posseduta dall’uomo, ma un’elargizione dell’amore di Dio, l’uomo deve far sì che lo Spirito possa agire in lui, lasciandosi guidare.(14)
Dopo la morte di Dio allora? Come discernere tra il bene il male, tra la virtù e il vizio? Don Leo è il protagonista di una tragedia contemporanea, nell’eterna attesa di un Deus ex machina che non arriverà mai, come in Beckett. Nell’epoca postmoderna si è giunti all’aporia del topos di Ercole al bivio, ovvero di quel momento decisivo in cui l’eroe si trova a dover scegliere tra l’invitante strada del Vizio e quella impervia della Virtù, narrazione che da una favola moralistica del sofista Prodico è diventata un tema ricorrente nelle arti (si pensi alla tela di Annibale Carracci, o alle opere di Raffaello e Tiziano)(15). Don Leo sembra alle soglie di un bivio in cui è possibile distinguere tra il bene e il male. È il dramma del contemporaneo: Ercole, seppur tentato dai piaceri del vizio, sa distinguerlo dalla virtù ed è libero di scegliere quale strada intraprendere. Il protagonista di Siti invece, seppur cerchi di agire rettamente soffocando il desiderio, “provoca” la morte di Andrea, che non accetta il suo rifiuto e si uccide. Michela Marzano nella sua recensione per “Repubblica” critica aspramente l’autore per questa scelta:
Che cosa suggerisce allora Siti in Bruciare tutto? Che è meglio dannarsi l’anima facendo sesso con un bambino che istigare a un suicidio?(16)
Il punto forse non è questo. Il punto è che in un mondo dove Dio non c’è i confini tra il giusto e lo sbagliato sfumano nella “zona grigia”(17) di cui parlava Primo Levi; e a volte, i risvolti possono essere tragici.
Bauman fa un discorso simile, seppur restando sul piano dell’immanenza, e in “Modernità liquida”cita una versione apocrifa di Lion Feuchtwanger dell’episodio dell’Odissea in cui Ulisse restituisce le sembianze umane ai marinai trasformati in porci dalla maga Circe. Elpenore, il primo a tornare umano, inveisce così contro il suo salvatore:
Vuoi tornare ad affliggerci e tormentarci, desideri ancora esporre i nostri corpi ai pericoli e costringere i nostri cuori a prendere sempre nuove decisioni? Com’ero felice; potevo sguazzare nel fango e crogiolarmi al sole; potevo trangugiare e ingozzarmi, grugnire e stridere, ed ero libero da pensieri e dubbi.(18)
L’età moderna ha invocato a gran voce la libertà, ma ben presto ci si è accorti che la coercizione sociale è la forza emancipatrice e la sola speranza di libertà che risparmi una “perpetua agonia di indecisione correlata a uno stato di incertezza”(19). I modelli imposti dalle pressioni sociali risparmiano la fatica di assumersi responsabilità e sostenere pressioni. Non solo non c’è contraddizione tra dipendenza e liberazione, ma la seconda, nella visione di Bauman, non esiste senza la prima. “Le regole possono dare o sottrarre autorità; l’anomia ha un effetto esclusivamente esautorante”.(20)
Quando
però ogni speranza di totalità svanisce, con la modernità liquida, l’essere
umano non è più caratterizzato (come in passato) dalla società, l’agenda
dell’emancipazione è stata estinta e i grandi valori veicolati dalle
istituzioni hanno perso il loro potere.
Note
(1) D. Alighieri, La Divina Commedia, a cura di G. Petrocchi, Bur, Milano 1989.
(2) W. Siti, Bruciare tutto, Bur, Milano 2017.
(3) S. Žižek, Pedofilia. Il segreto sessuale della Chiesa, Mimesis, Milano 2019, p.69.
(4) Ibidem, p. 75.
(5) Ibidem, p. 52.
(6) Francesco, benedetto XVI, Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia, Cantagalli, Siena 2019, p. 102.
(7) Ibidem, pp. 33-58.
(8) Siti, Bruciare tutto, p. 172.
(9) Ibidem, p. 175.
(10) Žižek, Pedofilia, p. 29.
(11) Ibidem, pp. 31-32.
(12) L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, a cura di Campailla Sergio, Newton Compton Editori, Roma 2015, p. 132.
(13) E. Bianchi, L’arte di scegliere, San Paolo, Milano 2018, pp. 15-16.
(14) Ibidem, pp. 45-48.
(15) E. Panofsky, Ercole al bivio e altri materiali iconografici dell’Antichità tornati in vita nell’età moderna, a cura di Ferrando Monica, Quaderni Quodlibet, Quodlibet, 2010.
(16) https://www.repubblica.it/cultura/2017/04/13/news/pedofilia_walter_siti-162874167/
(17) P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 2007, p. 24.
(18) Z. Bauman, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma 2011, p. 6.
(19) Ibidem, p. 9.
(20) Ivi.
Bibliografia
Alighieri Dante, La Divina Commedia, a cura di Petrocchi Giorgio, Bur, Milano 1989.
Bauman zygmunt, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma 2011.
Bianchi Enzo, L’arte di scegliere, San Paolo, Milano 2018.
Francesco, benedetto XVI, Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia, Cantagalli, Siena 2019.
Levi Primo, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 2007.
Panofsky Erwin, Ercole al bivio e altri materiali iconografici dell’Antichità tornati in vita nell’età moderna, a cura di Ferrando Monica, Quaderni Quodlibet, Quodlibet, 2010.
Pirandello Luigi, Il fu mattia Pascal, a cura di Campailla Sergio, Newton Compton Editori, Roma 2015.
Siti Walter, Bruciare Tutto, Bur, Milano 2017.
Slavoj Zizek, Pedofilia. Il segreto sessuale della Chiesa, Mimesis, Milano 2019.
Sitografia
https://www.repubblica.it/cultura/2017/04/13/news/pedofilia_walter_siti-162874167/