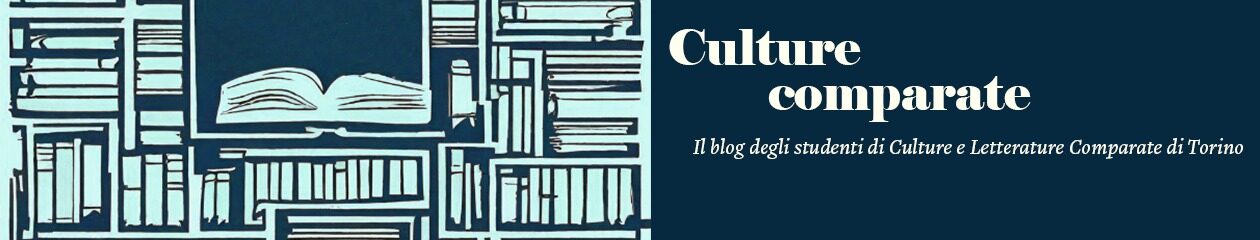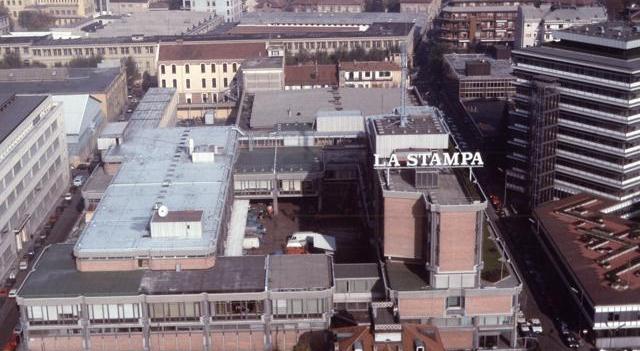Citato in
Con la chiave della scienza, 1985, PS, II: 1631
Passo
[…] a Italo devo molto. Quando era redattore presso la sede torinese di Einaudi, era per me naturale fare capo a lui. Lo sentivo come un fratello, anzi, come un fratello maggiore, benché avesse quattro anni meno di me. A differenza di me, era del mestiere: lo aveva nel sangue. Figlio spirituale di Pavese, ne aveva ereditato l’esperienza editoriale, la severità, il giudizio risentito e rapido. Le sue dritte, i suoi consigli, non erano mai generici né gratuiti.

*
Nella formula chimica che lega Primo Levi alla letteratura, non bisogna dimenticare di inserire anche l’elemento metaforicamente rappresentato dall’editore: senza, Levi non sarebbe nemmeno riuscito a pubblicare il suo primo live, non avrebbe guadagnato alcuna visibilità con la riedizione del suo primo capolavoro e non sarebbe stato così noto nel dibattito pubblico del suo tempo. Nel centro di Torino si trovano tutte e tre le case editrici che furono importanti nella sua carriera di scrittore: luoghi in cui doveva recarsi per conoscere i suoi editor, confrontarsi con loro e discutere le linee d’azione da intraprendere. Nel suo pluriennale rapporto con il settore editoriale, infatti, Levi seppe ben sfruttare le proprie carte (letteralmente) e riuscì a pubblicare molti (se non l’insieme intero) dei suoi lavori.
Il torinese Giulio Einaudi, che aveva fondato l’omonima casa editrice ancora oggi incredibilmente attiva, è sicuramente una delle personalità che possiamo avvicinare allievi secondo questo punto di vista: la storia del chimico-scrittore con questo editore è decisamente travagliata e già a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta, quando, appena tornato dal campo di sterminio è ancora versato giorno e notte dalla trappola dei ricordi, Levi stende il suo primo capolavoro, Se questo è un uomo. Nonostante i molti racconti fatti agli amici e alle persone per strada, o sui treni, sentendosi alla pari del Vecchio Marinaio di Coleridge, il reduce avrebbe un estremo piacere che la sua prova (testimoniale e, secondo le sue intenzioni, tutt’altro che letteraria) acquisisse una forma vera e propria, una forma-libro incanalata in un oggetto materialmente esistente, dunque non più un aleatorio racconto improvvisato sul momento. È proprio in virtù di questo desiderio che propone la sua creazione alla casa editrice Einaudi: dove, però, viene amaramente stroncato, e il suo sforzo non riconosciuto.
Appare oggi eclatante la misura in cui Einaudi e i critici che rifiutarono la proposta di Levi si sbagliavano: nel frattempo, Franco Antonicelli approfittò della circostanza favorevole e nel 1947 diede una vitale opportunità editoriale al reduce, stampandone il libro presso la sua casa editrice. Levi non era comunque intenzionato a demordere: tanto che, undici anni dopo (nel 1958), Einaudi ritornò sui propri passi e rivalutò la proposta di pubblicazione. Ne nacque un’edizione ampliata di Se questo è un uomo, la stessa che leggiamo ancora tutt’oggi.
Iniziò qui la fitta collaborazione tra Levi e l’Einaudi, che divenne il suo editore ufficiale: pressoché tutti i suoi lavori sono apparsi per i suoi tipi, oltre a diverse edizioni scolastiche dei suoi volumi più gettonati. Se per il primo volume Levi dovette subire il calvario dell’ascesa in salita, così non fu per le seguenti iniziative editoriali: divenne un autore di spicco già a partire dalla Tregua, nel 1963, che si poneva come naturale prosieguo del primo libro, per approdare poi alle raccolte di racconti, assumere sempre più rilevanza con il Sistema periodico e con tutti gli altri volumi successivi, fino a chiudere circolarmente la trattazione della vicenda concentrazionaria con la pubblicazione dei Sommersi e i salvati (uscito circa un anno prima della scomparsa di Levi).
Ma il chimico-scrittore non fu soltanto un autore per la casa editrice: più e più volte fece da editor esterno, valutò manoscritti, diede pareri editoriali, siglò prefazioni e produsse traduzioni (che gli valsero tanta ammirazione anche fuori dall’Italia). Fu questa una opportunità incredibile: gli permise di conoscere da vicino le pratiche editoriali e di partecipare in prima persona alle attività della casa, non solo conoscendo E stringendo forti rapporti con molte persone, ma anche modi di intendere la cultura legata al mondo dei libri. Non è infatti un caso che Einaudi volle tirarlo in ballo in diverse iniziative editoriali che caratterizzano la sua storia: ricordiamo, ad esempio, l’antologia personale La ricerca delle radici (1981) per la stesura della quale levi fu incaricato editor di se stesso; buona partecipazione alla collana Scrittori tradotti da scrittori, in cui dovette cimentarsi nella resa italiana del Processo di Kafka, che lo assorbì come un vortice.
Oltre ancora a ciò, il lavoro e l’assidua presenza alla casa editrice Einaudi diede a Levi l’opportunità di entrare in contatto con gli esponenti di spicco del circolo culturale ad essa legato: per fare due nomi tra i più importanti, Cesare Pavese e Italo Calvino (di cui l’estratto succitato è una parte dell’elogio funebre), entrambi molto importanti per l’opera di Levi. Se il primo era un modello stilistico e concettuale tramite cui comprendere meglio la letteratura, il secondo era invece il gemello asimmetrico con cui esplorare i misteri del mondo e dell’universo divertendosi grazie al potere delle parole.
Non risultano a questa ricerca, purtroppo, passi dell’opera di Levi in cui venga descritto gli edifici che ospitarono la redazione della piccola casa editrice durante i periodi di permanenza a Torino (mentre il nome ricorre più volte nelle interviste, ma soltanto in relazione alla riedizione di Se questo è un uomo). Ciononostante, l’indirizzo della sede storica (nella centralissima via Bertola) è stato tramandato ed è arrivato su più di un articolo di giornale. Ci sono diverse testimonianze ufficiali che dimostrano l’effettiva frequentazione di questo luogo da parte di Levi (specie nelle interviste, alcune delle quali si svolsero proprio nella sala conferenze einaudiana), e possiamo essere più che certi che si ritrovò a frequentare quei locali in ben più di un’occasione: sembra quasi di vederlo, mentre tira dritto e percorre verso nord quasi tutta la linearità di corso Re Umberto, assecondando le linee che scandiscono l’ossessiva geometria torinese, fino ad arrivare direttamente nella traversa di via Biancamano, dove dopo la guerra Giulio Einaudi vuole piazzare la sua casa editrice (trasferendola dai locali di via dell’Arcivescovado, dov’era invece sorta).