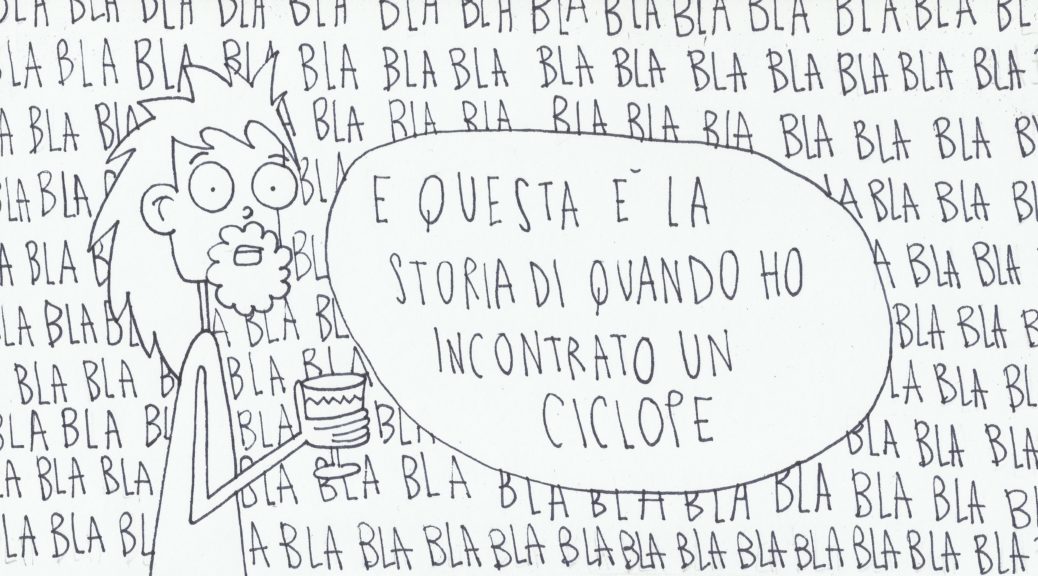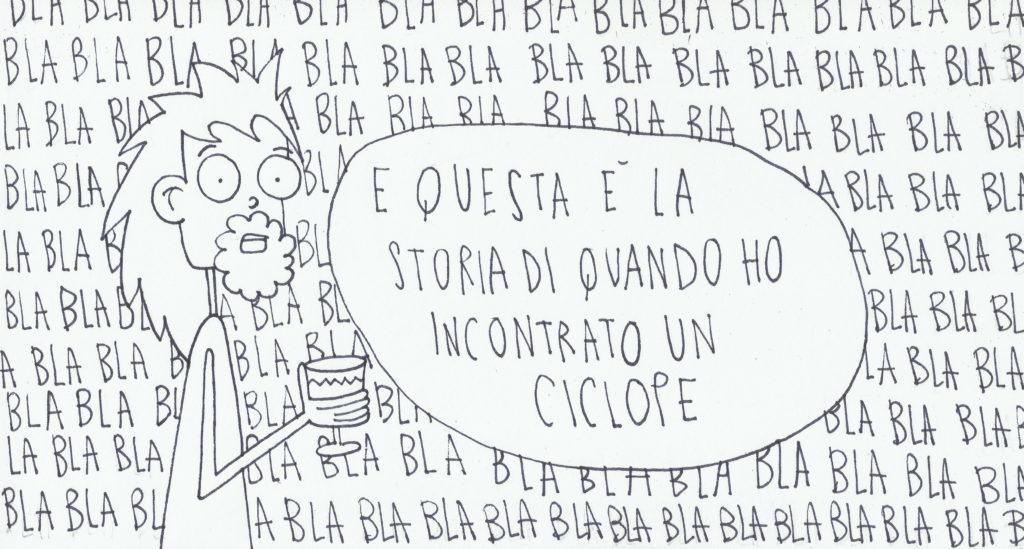Barbara Bo, in questa sua composizione, riscrive in un’inedita prospettiva i quattro drammi romanzeschi di Shakespeare, nell’ottica dei corsi I drammi romanzeschi di Shakespeare I e II: Pericle, Cimbelino, Il racconto d’inverno e La tempesta, Letterature Comparate B, modd. 1 e 2, prof.ssa Chiara Lombardi.
Innogene, Guiderio, Arvirago, Antonio e Sebastiano si trovano in un giardino immaginario e simbolico, di carattere onirico, dove sono portati a riflettere sul rapporto fraterno dalla visione di due bambini.
*
Una rondine scendeva planando dolcemente verso il prato illuminato dal sole. All’ombra di una grossa quercia due bambini si riposavano appoggiati alle radici come tra le braccia affettuose di una madre; parole gentili sussurrate attraverso le foglie risvegliavano le risa dei bambini. Innogene si avvicinò attirata dal campanellio lieve ma, più gli andava incontro, più l’albero risultava lontano, irraggiungibile; si voltò verso i fratelli: “Guiderio! Arvirago! Venite a vedere!”.
Mentre i due giovani si avvicinavano il suono si insinuò dentro di loro dove trovò il ricordo di sé stesso e riportò alla mente un tremore incontrollato e la richiesta esigente di un sospiro. Sorridendo, Guiderio affermò: “Sono fratelli! Se anche non avessero gli stessi capelli del colore del grano, se anche nei loro occhi non ci fosse memoria del medesimo bacio materno e dello stesso sorriso paterno, si riconoscerebbe comunque che quelle risa nascono dalla necessità di tutti i fratelli di volersi bene, tanto che paia non conoscano nient’altro.”
“Forse uno dei due ride, sì, ma solo per nascondere le sue vere intenzioni” interruppe un uomo, detto Antonio, avvicinatosi, il capo chino, in volto un’espressione priva di tenerezza. “Non c’è nulla di più facile che ingannare un fratello che vive per dare fiducia: se mio fratello fosse disteso accanto a me sotto quell’albero, con ogni sorriso luminoso io tramerei un piano brillante, e, con l’ausilio del caso, arriverebbe il momento in cui il suo affetto diverrebbe il mio guadagno, e il mio inganno il suo difetto.”
Quelle gelide parole provocarono in Innogene un’emozione tale da farla tremare: “O crudele straniero! Come si può leggere sulle labbra di quell’angelo, che ora sta lì, correndo felice dietro al fratellino più piccolo, una simile oscurità d’animo? Il fanciullino non scappa per terrore, affatto, scappa per un gioco che gli insegna a vedere la differenza fra compagno e nemico.”
Un secondo uomo si avvicinò ad Antonio, ridendo alle parole della ragazza: “Compagno tu dici? A me sembra che la corsa intrapresa da quel bimbo non sia diversa da quella che intraprende un condannato a morte di fronte al boia. Fratello può essere anche colui che ti ispira ribrezzo: non si combatte con lui per primo per l’affetto dei genitori? Io, Sebastiano, non esiterei a uccidere mio fratello per il potere, e così potrebbe fare quel pargoletto in futuro. Certo, ora corre e gioisce, ma le risa svaniscono quando devono affrontare il passare del tempo come un disegno sulla sabbia al vento”.
Arvirago rispose infervorato: “Cosa significa potere? Potente è la malattia che consuma il corpo, potente è la tempesta che distrugge la foresta. Ma entrambe hanno fine, sono contingenti, sono destinate alla sconfitta. Il legame fraterno, invece, non può terminare, esso è, per sua stessa natura, punto di partenza assoluto perché nasce con il primo respiro di una persona ed è quindi indissolubilmente legato alla vita.”
Le parole di Arvirago furono interrotte da un leggero tonfo e dal pianto cristallino di uno dei due bimbi che, dopo essere caduto a terra, si abbracciava il ginocchio offeso, singhiozzando dolcemente. Il fratello gli corse incontro e gli si sedette vicino: agli angoli degli occhi gli luccicavano delle lacrime che minacciavano di cadere, ma gli angoli della bocca erano rivolti verso l’alto in un sorriso di conforto.
Innogene rispose guardando la quercia perché la vista dei suoi interlocutori non reggeva il confronto con la tenerezza dell’abbraccio sotto la quercia: “Non si può fingere quel dispiacere. Un ginocchio sbucciato significa sia un graffio nella carne sia uno strattone per chi, come quel bambino che ora stringe e cerca di consolare il fratellino, sente nel sangue il dovere di proteggere più forte di qualunque altro istinto. È un obbligo che proviene da una promessa fra una madre e la natura: ella con il dolore del parto si assicura che il suo bambino sarà nel mondo amato da qualcuno e in cambio la natura lascia la stessa impronta sui figli dello stesso seno.” Si girò verso Arvirago e Guiderio. “Per questo un fratello è capace di riconoscerne un altro senza il bisogno di alcuna prova: sotto la pelle io riconosco questi miei fratelli al di là di ogni travestimento, tant’è che se dovessi scordare i loro nomi, identificherei il loro dolore come mio.”
I tre si scambiarono a loro volta un abbraccio, ignorando gli altri due uomini che li fissavano con aria sprezzante. Sebastiano disse quasi ridendo: “Non sono figlio unico, ma l’unica persona che sento di dover proteggere sono io. Si nasce soli, e così si vive: non vi è nessuna somiglianza fra gli uomini, siamo tutti stranieri che viaggiano nel mondo, e se pensate che vi siano dei legami intrinsechi che permangono al di sopra di tutto, siete degli illusi che cercano di trovare una goccia di acqua dolce nel mare”.
Innogene, le cui convinzioni non erano affatto messe in dubbio da quelle parole ostili, rispose tranquilla: “Se tu avessi ragione, e i sentimenti fra quei due bambini fossero un’illusione, perché mai adesso uno starebbe cercando di consolare l’altro come se la sua vita dipendesse da questo? Con i sorrisi, con le smorfie volte a provocare il riso? E guarda come si prepara a raccontare una storia che potrà sicuramente distrarre dal dolore e risollevare l’umore! E ascolta come, non sentendo di aver fatto abbastanza decide di cantare questa filastrocca che ora non può far altro che scaldare anche il tuo cuore gelido!”
La voce angelica del fanciullo li avvolse, accompagnata dal vento che frusciava attraverso le foglie; il racconto cavalcava il vento e riempiva di meraviglia i presenti. Il bimbo cantava di due rami che, provenendo dallo stesso albero si misero a giocare e giocando crebbero grandi e forti, fino a staccarsi per girare il mondo. Il bambino tornò a ridere, complice la memoria labile propria della sua età, e intraprese un nuovo gioco con il fratello.
Antonio non riuscì ad accogliere il sentimento lieto che li circondava, forse perché risvegliava una mancanza dentro di sé. Invece che sorridere, si mostrò irritato e ancora sostenne: “Si potesse rappresentare meglio l’illusione rispetto a ciò che è davanti ai miei occhi! Canzoni, affetti, giochi, favole… Tutti esempi di ciò che gli sciocchi credono sia importante quando sono troppo deboli per inseguire il potere e controllare chi è così sciocco da non farlo. Chi pensa solo a sé, lasciandosi alle spalle anche i vincoli familiari, vedrà che niente di buono vale la pena di essere condiviso, se non per necessità o convenienza!” Fece allora un cenno a Sebastiano che annuiva concorde.
Innogene, che aveva perso nuovamente il sorriso, parlò in un impeto di compassione: “Il mio cuore piange per voi che non avete mai amato un fratello! Il fato non vi ha mai mostrato il vostro difetto? O forse, non potete capire per stoltezza di cuore o di mente? O forse ancora il vostro animo non è abbastanza nobile da conoscere un così nobile amore, e di questo mi dispiaccio e prego che possa cambiare.” Arvirago si mosse verso la sorella: “Innogene cara, non sprecare il tuo pianto per questi uomini che non riuscirebbero a riconoscere la verità neanche se fosse una montagna sul loro cammino, vieni, calmati. In quanto a voi, penso che mia sorella abbia ragione: il più umile degli schiavi giudica suo fratello come il più prezioso dei tesori se il suo animo è abbastanza virtuoso da consentirglielo. Voi, al contrario, siete consumati dall’egoismo e nulla potrà mai cambiare la vostra opinione. Forse un giorno incontrerete i vostri fratelli, e doverli affrontare vi costringerà a testimoniare le vostre vite corrotte dall’odio, più che inebriate dall’affetto. Arrivederci.” Così dicendo i due fratelli si voltarono e iniziarono a camminare.
Innogene, però, ebbe un ultimo atto di esitazione, si fermò e tornò sui suoi passi per dare un abbraccio ad Antonio e Sebastiano: “Vi regalo questo abbraccio in quanto nel mio cuore risuona la speranza che come un bosco, che in autunno cambia il suo colore, anche voi possiate un giorno cambiare. A presto.” Si ricongiunse quindi ai due uomini poco lontani, andandosene con loro.
I bambini si erano infine addormentati, le loro gambe intrecciate come radici della quercia che li ricopriva con
le sue foglie.
Bibliografia
W. Shakespeare, Cimbelino, in Id., Tutte le opere. IV – Tragicommedie, drammi romanzeschi, sonetti, poemi, poesie occasionali, a cura di F. Marenco, Milano, Bompiani, 2019.
W. Shakespeare, La tempesta, ibidem.