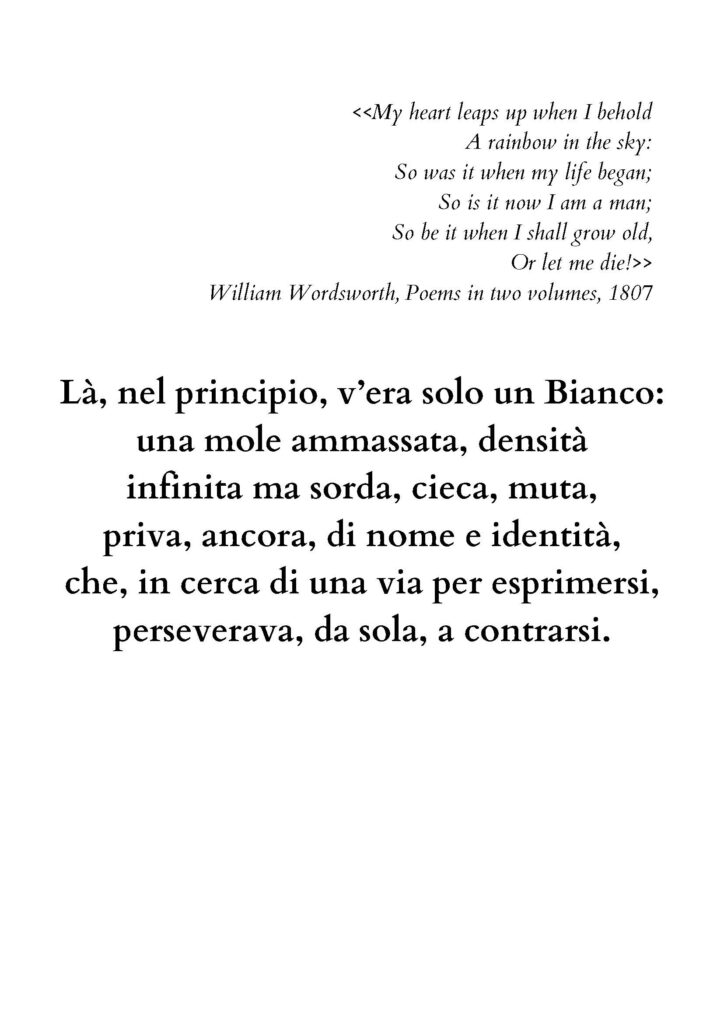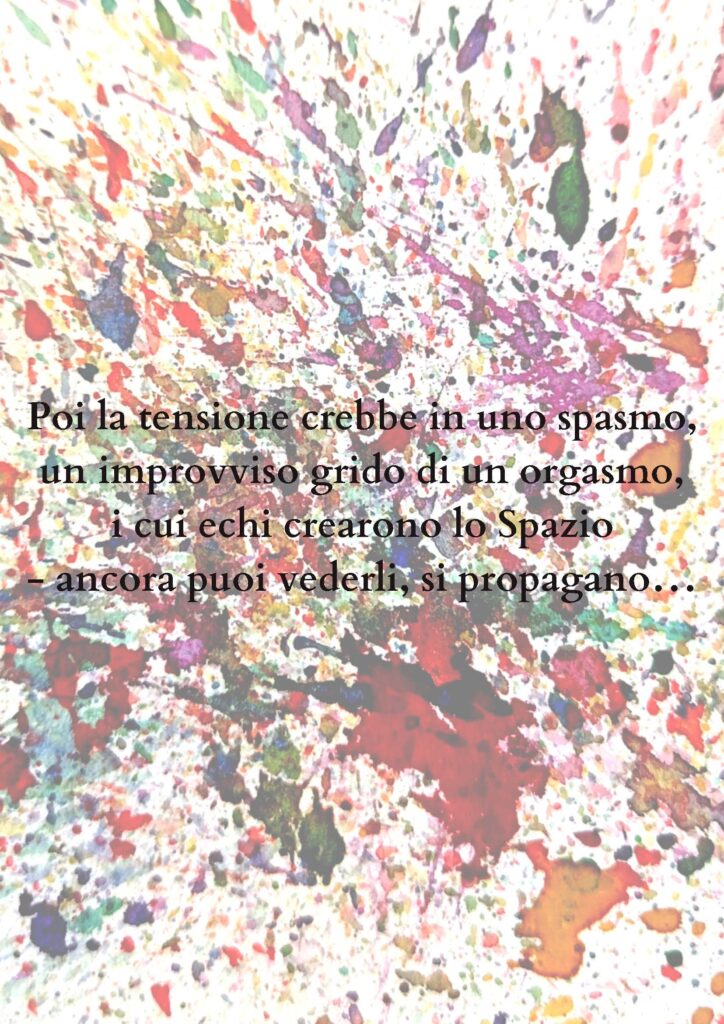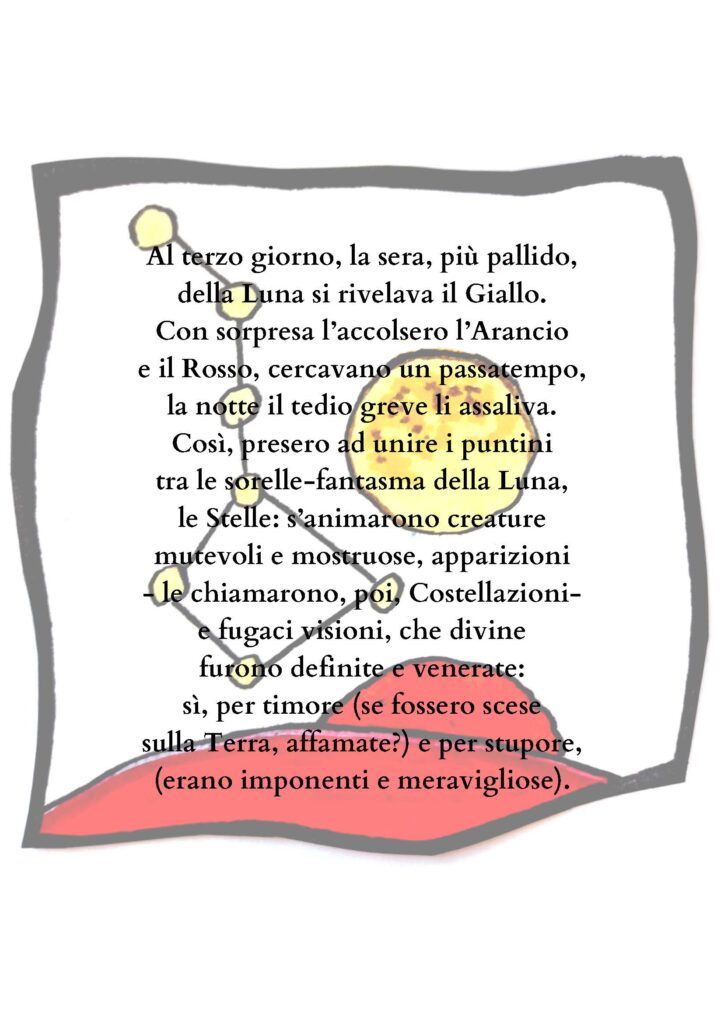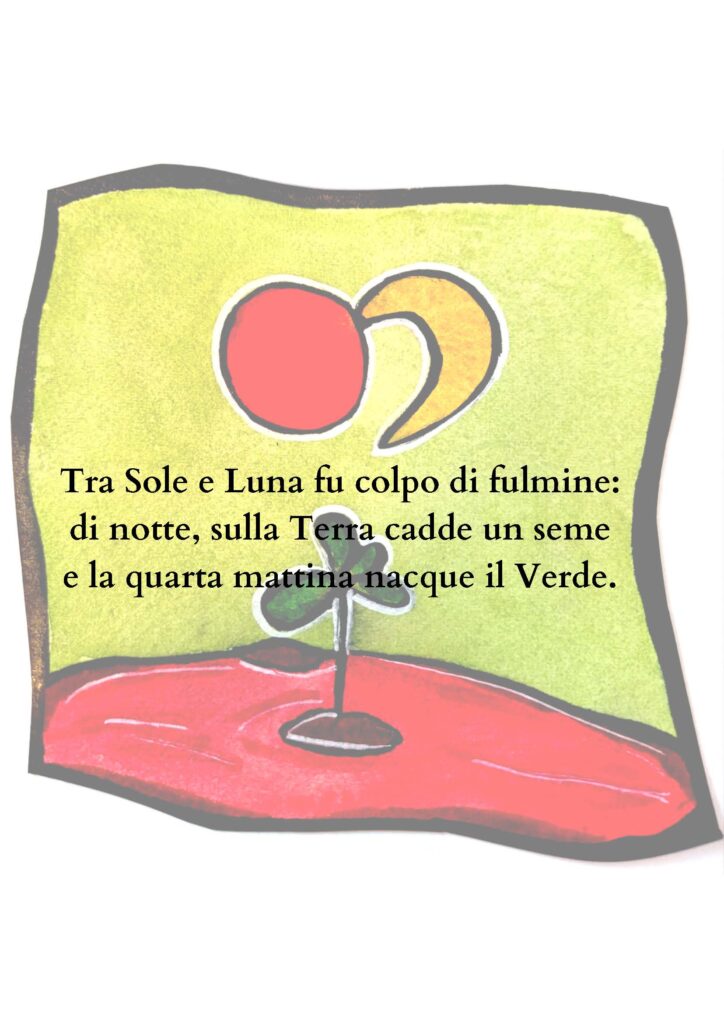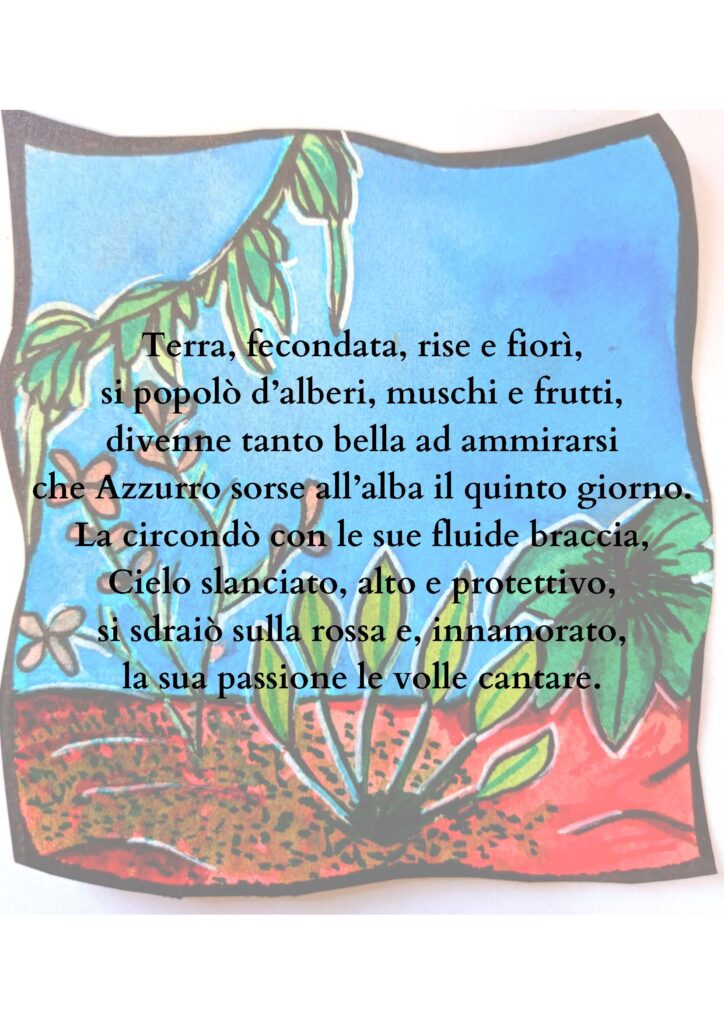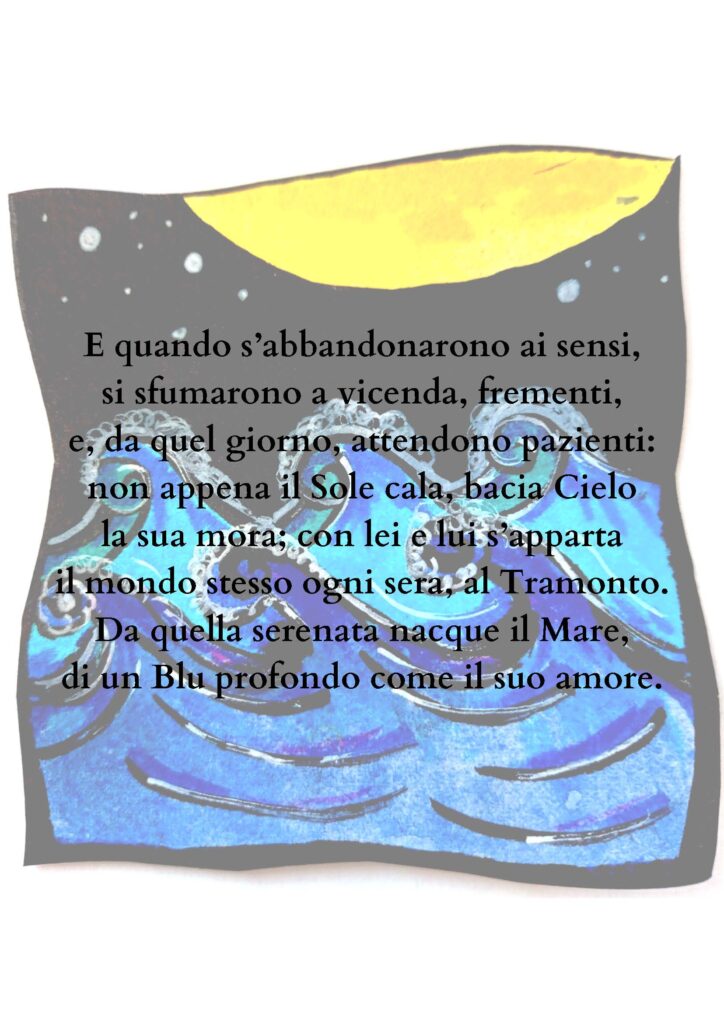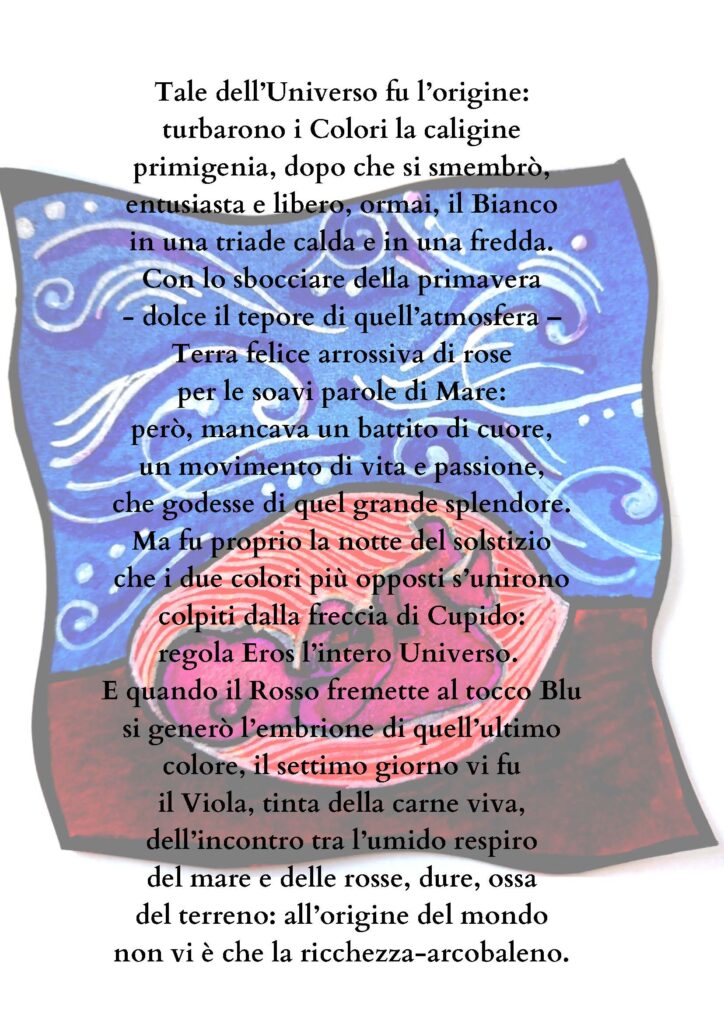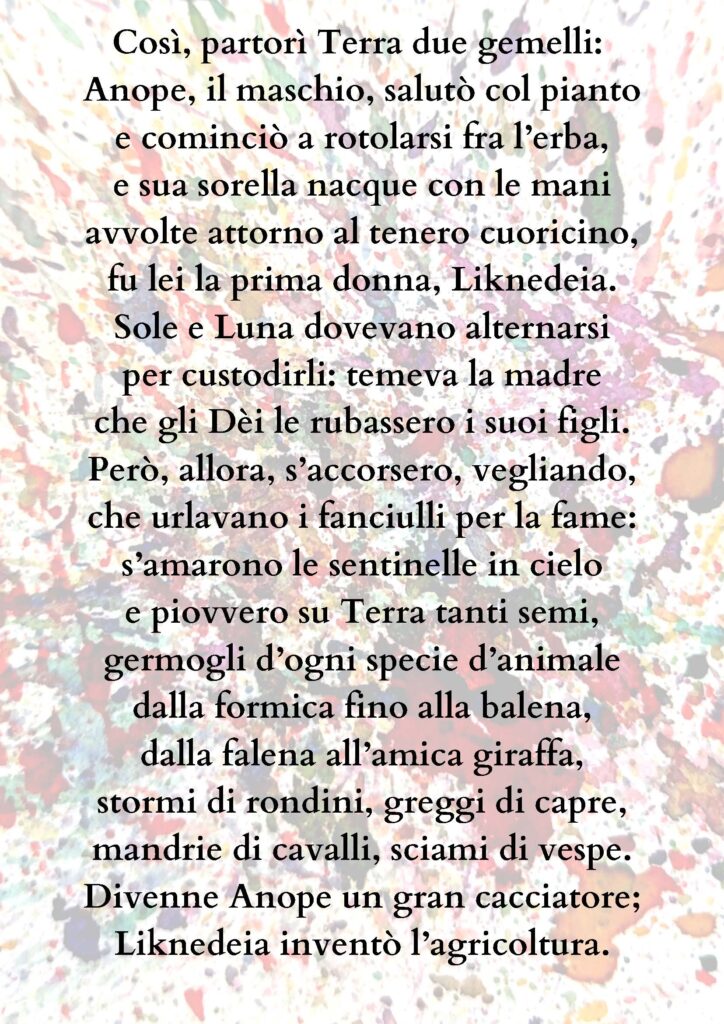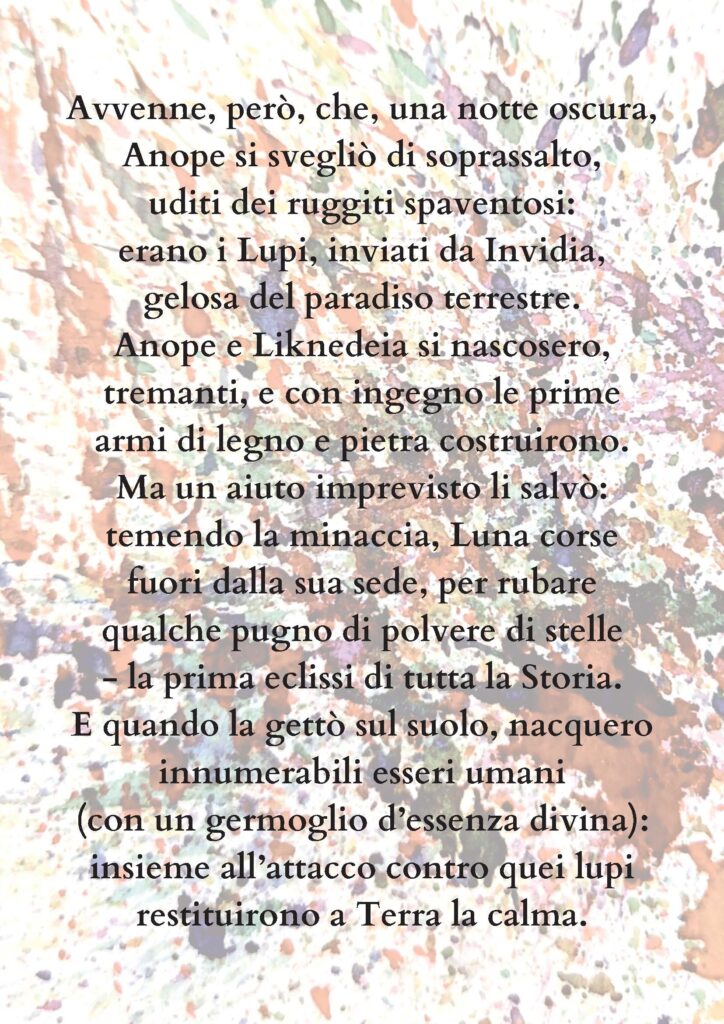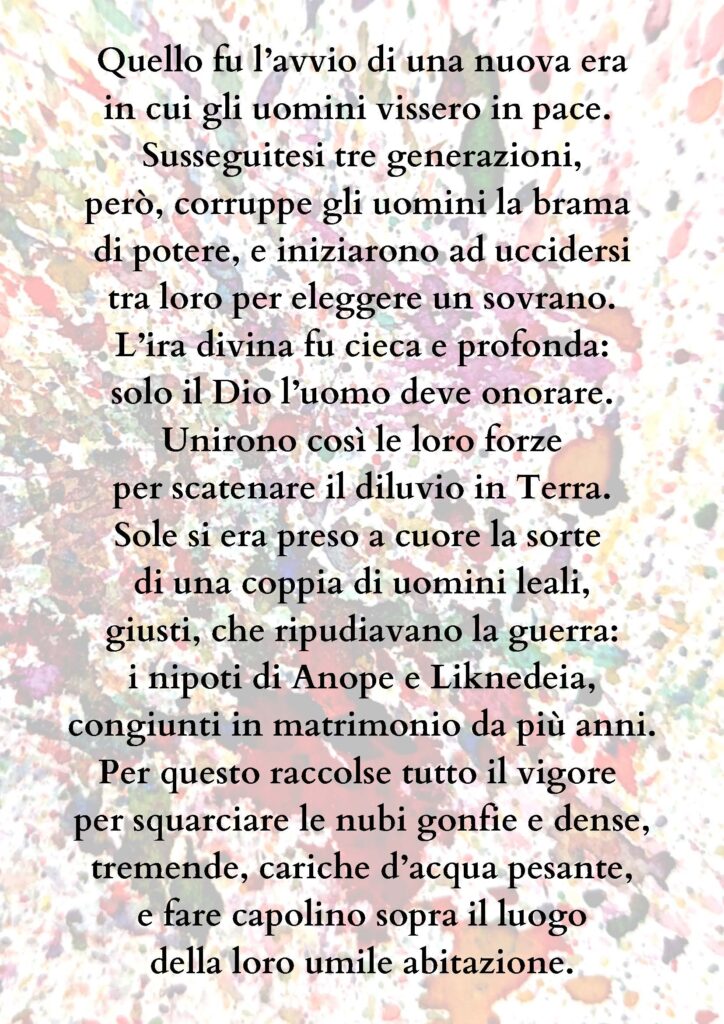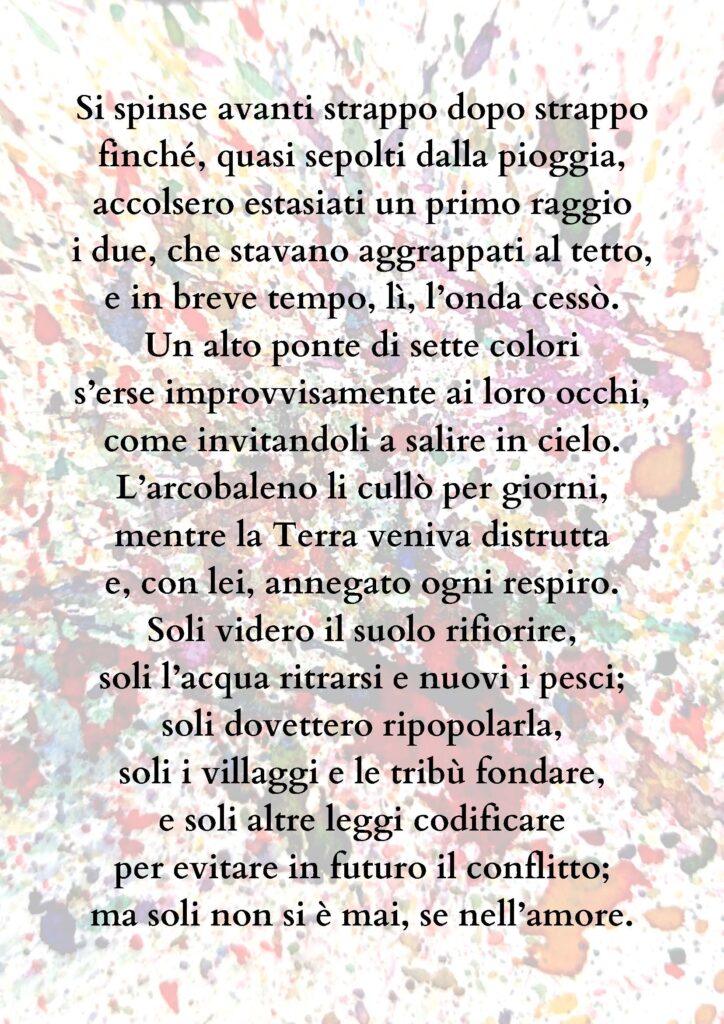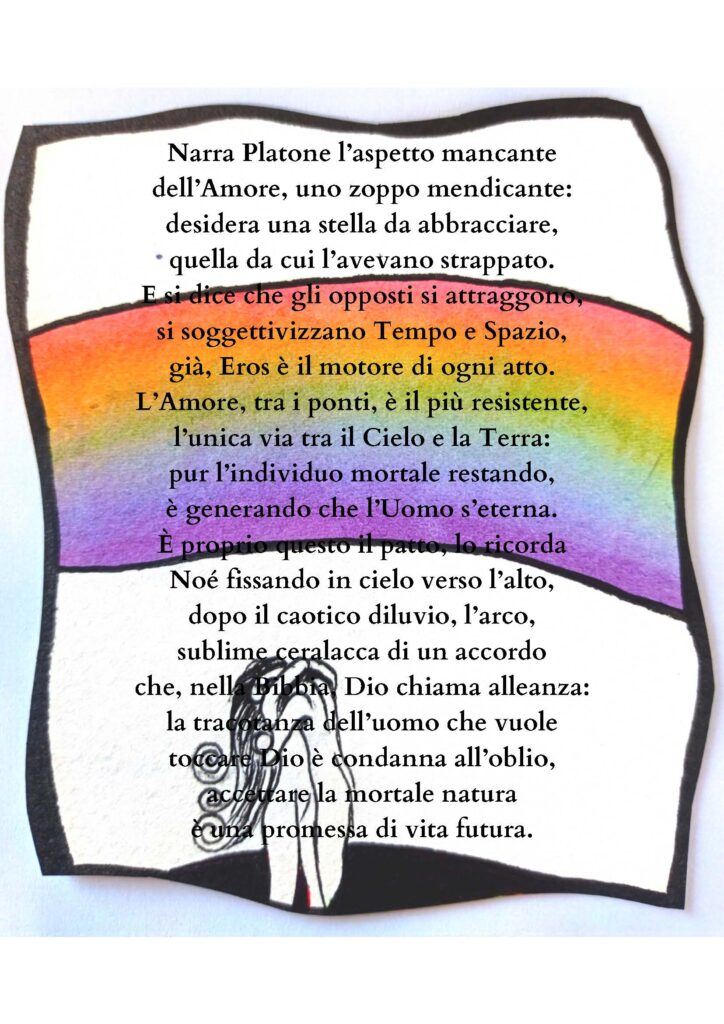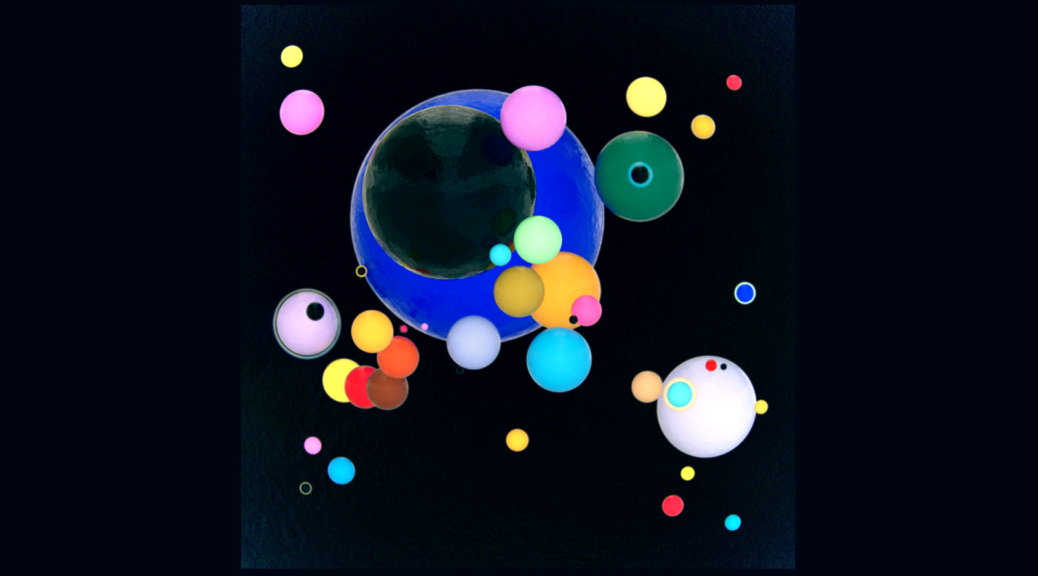Luca Piscioneri studia Culture Moderne Comparate presso l’Università degli Studi di Torino. Si è laureato in Culture e Letterature del Mondo Moderno nell’a.a 2018-2019 con una tesi in Letteratura Italiana, legata all’ambito della critica letteraria, dal titolo Le letture politiche della Mandragola di Machiavelli: storia di un’interpretazione.
Il presente lavoro contiene una lettura critica del romanzo Gli incendiati di Antonio Moresco coerente con le linee di ricerca emerse durante il corso di Letterature Comparate (a.a. 2019-2020) della professoressa Chiara Lombardi. Passando in rassegna i temi del fuoco, del bruciare, del viaggio e della fuga dalla schiavitù, fortemente presenti nel romanzo, la lettura che Piscioneri propone de Gli incendiati di Moresco argomenta attraverso alcuni contributi critici, sulla semiotica della città e sulla funzione del mito secondo Wu Ming, come sia possibile individuare il messaggio complessivo dell’opera e le sue forti implicazioni nella società attuale, arrivando a suggerire che si possa interpretare il testo come una sorta di nuova forma di mito moderno.
*
È difficile proporre un’interpretazione de Gli incendiati di Antonio Moresco senza analizzare
il tema del fuoco e senza chiedersi quale sia il suo significato all’interno
del romanzo. Quella del fuoco, infatti, è una presenza praticamente costante nell’immaginario
di Moresco e il romanzo in questione non è un’eccezione[1].
Consapevoli di ciò, volendo tentare di descrivere il mondo rappresentato all’interno
dell’opera, non si potrebbe fare a meno di aprire il discorso con alcune
riflessioni in merito al tema dell’incendio introdotto sin dal titolo.
Se il titolo Gli
incendiati implica un’azione compiuta, il mondo descritto nel romanzo è, al
contrario, un mondo in compimento o, per meglio dire, che ancora deve
compiersi. Perciò, per descriverlo, si potrebbero ragionevolmente usare gli
stessi aggettivi che definiscono i possibili stati di vita del fuoco: spento e domato. Seguendo questo parallelo, per via della differenza dall’immagine
in atto offerta dal titolo, in cui è
evocata l’idea del fuoco acceso, il mondo descritto nel romanzo appare invece spento perché non è ancora incendiato
oppure domato perché non è più incendiato.
In questo modo, il mondo descritto all’interno dell’opera risulta
dunque connotato da un aspetto disforico, mentre il fuoco appare come una forza
misteriosa che non possiede soltanto proprietà negative, bensì anche aspetti euforici.
Infatti, al contrario di quanto vorrebbe l’immaginario comune, il particolare
fuoco in questione non destabilizza soltanto nell’accezione negativa legata
alla sua pericolosità, ma, essendo connotato positivamente e data l’aura vagamente
vivificante con cui è descritto, destabilizza anche in un modo positivo. Cioè,
oltre ad essere in grado di distruggere, è anche una forza in grado di generare.
Alla luce di quanto introdotto, si può dunque sostenere
che, per questa sua natura ambigua, il fuoco descritto da Moresco appaia come
il motore della storia raccontata nel suo romanzo. Data la sua centralità, il
presente lavoro propone di analizzare l’immagine del “bruciare” al fine di
tentare così l’individuazione del significato complessivo dell’opera e, per far
ciò, verrà proposto di considerare l’immagine dell’incendio, specialmente per
via della sua capacità di generare cambiamento e di essere così motore della
storia, in relazione all’idea di mondo spento
o domato descritta nel romanzo.
1. Il fuoco e l’avventura
Data la loro ambigua natura, le fiamme descritte da
Moresco, proprio per via della sensazione di totale incertezza che pongono in
essere nel romanzo, sono in grado di creare un stato di eccezione capace di
innescare il processo che arriva a sovvertire l’ordine vigente, o per meglio
dire, data la rappresentazione fortemente disforica dello scenario, il disordinevigente. Questo particolare stato
d’eccezione che permette il realizzarsi delle condizioni da cui scaturiscono
gli eventi nella trama lo si potrebbe chiamare avventura; così, si potrebbe dire che nel romanzo di Moresco l’avventura è generata dall’incendio.
Infatti, è proprio l’incendio a far sì che si realizzi il
primo vero incontro del protagonista con la donna dai denti d’oro e, ad
avvalorare l’idea di incendio come mezzo in grado di mettere in movimento la
narrazione, si scopre leggendo che è proprio la stessa donna dai denti d’oro ad
averlo appiccato volontariamente per
conoscere il protagonista[2].
In generale, si può vedere che il fuoco è presente sotto forma di incendio
dilagante in tutti i momenti di svolta della narrazione, ossia in quei momenti dove
la trama segue un percorso e ne abbandona irreversibilmente un altro.
Per esempio, lo si può vedere anche in occasione del sogno
in cui si realizza l’onirica prima notte di passione carnale fra i due
protagonisti, dove l’incendio circonda i due amanti e fa da sfondo alla
descrizione del loro pornografico amplesso; a seguito di quel sogno,
l’ossessiva ricerca della donna dai denti d’oro da parte del protagonista
maschile sembra suggerire l’irreversibilità del ritorno alla vita com’era prima
dell’incendio che li ha fatti incontrare.
Tuttavia, il punto cruciale in cui il manifestarsi dell’incendio
rappresenta maggiormente l’impossibilità di ritorno allo stato di cose
precedente è quanto accade a seguito dell’esplosione della villa del Cacciatore
di schiavi. In questa scena, il fuoco dell’esplosione creata dai due protagonisti,
proprio perché innesca la loro immediata fuga in auto dalle labirintiche strade
della città di notte e fa da preludio alla loro uccisione da parte dei
mercenari del Cacciatore, può essere visto come emblema del processo
inarrestabile e irreversibile della loro storia.
Alla luce di quanto detto sin ora, si è tentati di dire
che in Moresco tutte le idee legate all’immagine del fuoco, quali l’idea di
luce, di calore, di caos e persino di distruzione, siano indistintamente disegnate
con tinte positive; tuttavia è necessaria una precisazione. La positività in
questione non è riconducibile ai risultati che l’incendio ha posto in essere
una volta terminato, bensì è una caratteristica intrinseca dell’incendio stesso
inteso come processo in divenire. In sostanza, il positivo del fuoco di Moresco
non è legato a ciò che resta dopo l’incendio, bensì al bruciare dell’incendio in atto: allo stato
di incertezza che sblocca la stasi e innesca l’avventura. Avventura che perciò sarà da intendere col significato di
“ciò che accadrà” derivante dal latinismo adventura[3].
2. Il fuoco, la materia
umana e la Storia
Per tutta la parte in cui i protagonisti sono in vita, nel
romanzo non compare l’idea di nessun avvenire; la massa di esseri umani che
viene descritta dalla voce narrante dell’eroe appare bloccata in uno stallo, una
sorta di veglia incosciente che la fa apparire al lettore semplicemente come
materia organica ambulante: materia sì vivente, ma di una vita vuota, una vita
che si potrebbe definire non-vita. Gli individui descritti sono materia senza
forma, la loro esistenza si trascina dunque senza un senso in un infinito
presente senza passato e senza prospettiva futura. All’idea di materia senza
forma e di condizione di vita senza finalità è collegato il tema schiavitù,
prepotentemente presente nel romanzo.
Presentato al lettore attraverso l’ambigua figura della
protagonista femminile, la donna circassa dai denti d’oro, il tema della
schiavitù porta all’estremo l’idea di una condizione umana intesa come vita-non-vita che
caratterizza la società descritta nel romanzo. Sembra di poter dire che per
Moresco, gli schiavi — uomini o donne che siano; caratterizzati dalla
trasgressione estrema come quelli descritti nella villa del Cacciatore o dalla
nullità più quieta come quelli “addormentati” della città o della località di
mare — rappresentino l’assenza di forma per
antonomasia: sono dunque solo materia informe e praticamente inanimata, per di
più neanche libera. Tuttavia, nel romanzo di Moresco, un modo di dare forma
alla materia esiste ed è proprio su questo punto che sembra vertere tutto il
peso del messaggio comunicato dal romanzo. La forma ha origine quasi
casualmente, ma necessariamente, dal contatto fra due materie umane informi
compatibili fra loro: dall’incontro del protagonista maschile e della protagonista
femminile.
I due eroi, come due reagenti chimici compatibili, come il
combustibile e l’aria comburente, reagiscono esattamente come in una reazione
chimica. Proprio come nasce il fuoco, da due materie senza forma scaturisce una
forma compiuta che è viva. La loro unione nel finale del libro, mistica unione
di due anime vive contenute nella materia dei loro corpi uccisi, innesca un
vero e proprio nuovo Big Bang che fa
nascere una nuova stella.
In sintesi, per via della sua essenza descritta all’inizio,
ossia per il suo essere motore di storie, generatore di avventura e per le idee di processo e di divenire che evoca, il
fuoco appare con le stesse caratteristiche di una reazione chimica. Del resto,
il fuoco è una reazione chimica e, in
quanto tale, innesca un processo che è in grado di generare qualcosa (fiamma,
luce, calore, anidride carbonica, una stella!) partendo da qualcos’altro: la
materia.
Il fuoco di Moresco, secondo la visione proposta, sembra
dunque in grado di donare forma e vera vita alla materia umana informe che vita
autentica non ha. È dunque un fuoco simbolico che accende ciò che è spento o
che è stato domato e che, se distrugge,
rimescola l’ordine — o il disordine— del
mondo. Le persone schiave e “addormentate” non si avvedono del suo incedere
inesorabile, o, nel raro caso in cui se ne avvedano, non sono in grado di coglierne
il senso e si limitano ad osservarlo incedere senza fare nulla e senza capire.
Sembra proprio questo il punto centrale del rapporto tra
fuoco, uomini-schiavi e storia, in cui emerge la metafora de Gli incendiati di Moresco.
Se il fuoco rappresenta la storia, il suo bruciare è così
lento da sembrare un rogo immobile e circoscritto. A prima vista, appare quasi
come se fosse inesistente — “è solo un fuoco” sembra dire chi lo vede —
ma, in realtà, il suo espandersi è costante e inarrestabile, talmente dilagante
che arriva inevitabilmente a raggiungere le dimensioni dell’incendio. Per via
della sua luce che quasi trasforma la notte in giorno e del suo tangibile
calore, solo allora risulta evidente ed enorme. Solo a quel punto gli schiavi e
la gente “addormentata” se ne avvedono e non possono fare altro che svegliarsi
di colpo in preda al panico. Così, inevitabilmente, la folla reagirà come se il
fuoco, che ormai è incendio, fosse apparso solo in quel momento. Cioè reagirà
in maniera convulsa e incontrollata, totalmente in balia di quello stato di
eccezione dato dalla consapevolezza di essere completamente impotenti di fronte
alla forza distruttiva dell’incendio, che spezza così tutte le certezze, la
routine e l’ordine — o il disordine — costituiti. Tuttavia, come si è
detto, oltre a questa capacità distruttiva, il fuoco manifesta anche delle
possibilità.
Per via della sua natura ancipite, che danneggia ma allo
stesso tempo offre possibilità, sembra che l’immagine del fuoco di Moresco possa
essere interpretabile come metafora della Storia. Infatti, la Storia, come la
il fuoco, nel suo manifestarsi sotto forma di evento traumatico, risveglia i
sensi dei corpi che in precedenza apparivano solo involucri vuoti e li pone di
fronte ad un imprecisato avvenire. Per questo, in quanto stato di incertezza tra
i più evidenti, l’incendio, nell’opera di Moresco, è osservabile in senso lato
come l’emblema di ogni evento storico sovversivo dell’ordine vigente, ma, proprio
per questo, appare anche foriero di possibilità in precedenza irrealizzabili.
È proprio qui, a mio parere, che si trova l’elemento
positivo del romanzo; viene paradossalmente proposta in contrapposizione alla
distruzione simboleggiata dall’incendio, la forza dell’incendio stesso, ma
vista da un’altra prospettiva, ossia come forza purificatrice e vivificante.
Ne Gli incendiati,
l’incendio-Storia appare così caratterizzato da una doppia connotazione, una
disforica e una, molto meno evidente, ma non meno presente e importante, assolutamente
euforica. Se si considera il fuoco di Moresco come metafora della Storia, si
potrebbe dunque dire, riprendendo l’idea nietzschiana, che la Storia possa
influire nelle alterne vicende degli uomini e del mondo sia in quanto danno e
sia in quanto utile.
Alla luce di quanto osservato sin qui e procedendo verso
la conclusione della trattazione, si può
finalmente riflettere su come interpretare questo potere distruttivo e
allo stesso tempo generativo del fuoco-Storia all’interno della vicenda narrata
da Moresco.
3. Il viaggio di
nozze e l’apologia del nomadismo
Una letteratura che vuole essere specchio del suo tempo non può non tenere conto della polverizzazione del contesto che cerca di riflettere, non può astenersi dal rispettare la natura confusamente mosaicata dell’immagine che tenta di riproporre. È pertanto necessario che la letteratura sfidi apertamente il paradosso di […] affrontare la compiuta rappresentazione di una società incompiuta.[4]
Con queste parole di Pasquale La Forgia sembra essere
descritto proprio l’obiettivo della scrittura di Moresco: “la compiuta
rappresentazione di una società incompiuta”[5].
Ne Gli incendiati,infatti, si viene a contatto con un
mondo illeggibile, un mondo estremamente organizzato, addirittura ordinato si potrebbe
dire, ma retto da un ordine invisibile di cui non si riesce a cogliere il
senso. Il mondo descritto da Moresco appare costituito da uno spazio
prevalentemente cittadino, in cui le strade, gli incroci, gli edifici, danno un
senso di reclusione in un labirinto senza uscita o, date le dimensioni
annichilenti dello spazio urbano, dall’uscita lontanissima. Risulta
particolarmente significativo il fatto che la coppia di eroi riesca ad uscire
da questo labirintico mondo cittadino soltanto dopo aver trovato la morte nella
sparatoria contro i soldati del Cacciatore di schiavi. Così, dopo la loro
morte, una volta entrati nella loro nuova forma di vita — che nel testo appare
provocatoriamente più viva rispetto alla precedente vita-non-vita — i
due personaggi iniziano il loro simbolico viaggio di nozze.
La descrizione del mondo labirintico in cui viaggiano
appare definibile secondo l’interpretazione semiotica dell’idea di città
proposto da Guido Ferraro, secondo cui
“città” è un territorio strappato al dato naturale, proiezione di un volere progettuale, punto di arrivo di un percorso di generazione culturale, sicché “città” sarebbe il punto di arrivo di un progetto continuamente in corso e continuamente ridefinito. Perché in definitiva l’obiettivo di questo progetto è il mantenimento — magari anche finzionale, illusorio, ingannevole se vogliamo — di una bengodi della virtualità: lo spazio del possibile, dell’incrocio tra tutte le identità e tutti i linguaggi, fra tutte le prospettive e tutti i programmi di vita.[6]
La trama de Gli incendiati
sembra essere stata costruita da Moresco al fine di evidenziare proprio l’aspetto
“finzionale, illusorio, ingannevole” che, come ha spiegato Ferraro, è legato
all’idea di vedere nel mondo “lo spazio del possibile” o “una bengodi della
virtualità”. Con la loro epopea, i due eroi moreschiani, in lotta contro il
mondo dei “vivi”, sembrano voler dire che la modernità, simboleggiata dallo
spazio urbanizzato, ossia “lo spazio del possibile”, sia al contrario lo spazio dell’impossibile dove l’uomo è
privato della sua singola identità, del linguaggio, delle prospettive e dei
programmi di vita. Nella visione di Moresco, l’uomo moderno è dunque ridotto in
schiavitù e secondo l’interpretazione proposta all’inizio del presente lavoro,
è spento o domato. Alla luce di questa lettura dell’opera, si può proporre di
vedere Gli incendiati di Morescocome una sorta di epopea o cosmogonia
moderna.
Come sostiene Massimo Leone, “se si concepisce la città
come un testo, passibile di continue scritture e riscritture, allora è lecito
chiedersi se questo testo possa essere cancellato, e in che modo”[7].
Le modalità con cui nelle narrazioni viene descritta la cancellazione di una
realtà urbana proposte da Leone sono: la profezia
catastrofica, che “enuncia in un tempo futuro la cancellazione di una città
presente, configurandosi, dunque, come racconto immaginario” e il resoconto del sopravvissuto, che “enuncia
in un tempo passato, o in un presente storico, la cancellazione di una città
passata o, per meglio dire, il tentativo di questa cancellazione”[8].
Ma non solo, Leone prosegue la sua trattazione sostenendo che ci sono altre due
modalità; modalità che alla luce di quanto proposto nel presente lavoro
sembrano essere più adatte ad identificare il tipo di narrazione de Gli incendiati.
L’annientamento del senso di un testo urbano può essere anche osservato e rappresentato secondo una prospettiva diametralmente opposta, che in un certo senso parteggi a favore dell’attante distruttore contro la città distrutta. Al pari della prima macro–categoria — quella che comprendeva profezie catastrofiche e resoconti del sopravvissuto — anche questa seconda può essere articolata in diversi tipi di testi; due sembrano meritare una particolare attenzione; li si potrebbe denominare “epopea di annichilimento” e “apologo del nomade”.[9]
Secondo questa proposta, si potrebbe rubricare Gli incendiati nel novero di queste
particolari narrazioni identificate con le etichette di “epopea di
annichilimento” e di “apologo del nomade”. In particolare, interpretando il
viaggio di nozze dei due protagonisti come reazione contro il mondo labirintico
e contro la condizione di vita-non-vita descritti nel romanzo di Moresco,
l’etichetta più opportuna per identificare Gli
incendiati appare proprio quella di apologo
del nomade, o meglio, apologo dei due nomadi. In sintesi, “l’annientamento del senso
di un testo urbano è osservato e rappresentato dall’esterno non solo nelle
epopee di conquista ma anche, […], in testi e racconti che, pur posizionando il
proprio punto di vista al di là dei confini della semiosfera urbana, non esprimono una logica di conquista bensì
un diverso atteggiamento culturale verso la città, qui denominato “apologo
del nomade”“[10].
Sembra quindi di poter affermare che il viaggio di nozze
dei due eroi moreschiani — viaggio che, come si è detto, può avere inizio soltanto
nel momento in cui i due protagonisti vengono paradossalmente risvegliati dalla
vita attraverso la loro morte — esemplifica proprio questa idea di “diverso
atteggiamento culturale verso la città” e, si potrebbe anche aggiungere, verso l’obnubilante
società in generale che caratterizza la modernità. In particolare, l’apologia
del nomadismo evocata dal loro viaggio di nozze, specialmente nell’ultima parte
del romanzo, diventa un atto sovversivo contro l’idea di città e di società
descritte da Moresco e culminerà nel finale con la metafora del fuoco scaturito
dall’incontro delle due materie umane dei due eroi. Nell’ultima pagina, infatti,
si creano le condizioni ideali per il compimento della reazione chimica
descritta in precedenza e può così avvenire l’estrema combustione da cui nasce
la stella, simbolo positivo di un nuovo corso.
4. Conclusioni: una
nuova forma di mito
Alla luce di queste proposte critiche, il fatto che
Moresco non ancori le vicende che descrive al realismo, preferendo una
costruzione della trama che volutamente non offre richiami chiari al mondo
reale, ma che tuttavia, nonostante ciò, riesce efficacemente ad evocare, sembra
permettere di sostenere che il romanzo Gli
incendiati abbia un ché del mito. In particolare, per via del loro
particolare stile, “quello che sembrano suggerire le opere di Moresco […] è
che, al di là della contrapposizione fra una solidità romanzesca orientata al
puro artificio finzionale e una comoda frammentazione narrativa che sa di
scorciatoia, si estende un ampio e squassato territorio di scritture impure e
ibridate, ma non per questo friabili o impersonali, che potrebbero
rappresentare una stimolante alternativa, per chi oggi volesse tornare a
misurare la propria scrittura con le imprevedibili mutazioni di un’Italia (e di
un mondo) ancora in gran parte da raccontare”[11].
Con la sua scrittura Moresco offre un’idea di letteratura
che sembra avvicinarsi molto a quella del collettivo bolognese Wu Ming.
Come riassume Stefano Giovannuzzi, nella posizione teorica
del collettivo,
L’appello ai fatti e alla realtà non è infatti sufficiente, non garantisce nulla. Oltre che fuori della portata dei più, i fatti e i documenti in quanto tali sono inerti: non parlano, e dunque non esistono, se non vengono collocati in un racconto che dia loro senso. Ed è questo il passaggio critico: se le narrazioni sistemano i dati in una prospettiva, l’uso più o meno legittimo, a volte del tutto fraudolento, che di esse si può fare riguarda molti, produce a getto continuo un immaginario che si sostituisce alla realtà e ne orienta la percezione[12].
Sembra che a questo “immaginario che si sostituisce alla
realtà e ne orienta la percezione” si possa associare tutta l’ideologia del
potere e del possesso rappresentati dal Cacciatore di schiavi e dal tema della
schiavitù trattati nel romanzo.
E se il discorso del potere (qualunque forma assuma) usa le narrazioni per alimentare l’immaginario bloccandolo entro paradigmi conformisti e totalitari, la finzione letteraria può rientrare in gioco per sbloccare l’orizzonte dell’immaginario, producendo narrazioni che disarticolano il processo di monumentalizzazione della storia e aprono il varco alla possibilità di una storia critica. Ciò non cambia la storia, ma ne modifica l’unilateralità della lettura e il conformismo in costruzioni aperte e continuamente modificabili dalla comunità dei lettori.[13]
Gli incendiati di Moresco, in ultima battuta, sembra
costituire una grande allegoria proprio di come “la finzione letteraria può
rientrare in gioco per sbloccare l’orizzonte dell’immaginario” e di come il
narrare la Storia o le storie — elaborate partendo da fatti reali o costituite
da elementi fantastici — possa modificare “l’unilateralità della lettura e il
conformismo”[14], del
mondo spento o domato, “in costruzioni aperte e continuamente modificabili dalla
comunità dei lettori”[15].
L’operazione che Moresco ha voluto proporre con Gli incendiati sembra dunque molto
simile, specialmente a livello di intenti, a quella di Wu Ming; Moresco infatti,
come Wu Ming, “non presume di rappresentare la verità, ma di offrire una
prospettiva che mette in crisi l’omologazione, i luoghi comuni, le narrazioni e
le mitologie che si sono solidificate nel tempo”[16].
Viene realizzata così, “un’operazione che coinvolge il lettore, che gli impone
un ruolo attivo nel ripensare la storia e, come in un cortocircuito, quello che
siamo oggi”[17].
Alla luce dell’idea di fuoco, di storia, di narrazione e
di mondo trattate nel presente lavoro, se si accetta la funzione che Wu Ming
attribuisce al mito, ossia “permettere al singolo e all’umanità di attraversare
la perdita del senso, verso la catarsi che darà inizio a un nuovo ciclo”[18],
appare possibile sostenere che Moresco abbia reso i suoi eroi protagonisti di
una sorta di nuovo mito moderno. Un mito moderno che, diversamente dal mito
classico proiettato verso un passato remoto, appare invece proiettato verso una
dimensione postuma in un imprecisato avvenire.
Bibliografia
Guido Ferraro, Oltre l’idea di città, in La città come testo: Scritture e riscritture
urbane, a cura di Massimo Leone,
Aracne, Roma, 2008, pp. 215-223.
Stefano Giovannuzzi, Realismo e letteratura: dalla parte di Wu
Ming, in “Comparative Studies in Modernism”, n. 9, 2016, pp. 45-53.
Pasquale La Forgia, Apocalissi nostrane: la critica italiana e la tentazione della fine,
in “Studi Novecenteschi”, Vol. 30, No. 66, pp. 305-355.
Massimo Leone, Signatim: Profili di semiotica della cultura, Aracne, Roma, 2015
Wu Ming 1, Breckenridge e il continuum, in Wu
Ming, Giap!, a cura di Tommaso De Lorenzis, Einaudi, Torino,
2003, pp. 16-18.
Antonio Moresco, Gli incendiati, Mondadori, Milano, 2010.
[1] “Carla Benedetti – a tutt’oggi il critico letterario
che ha dedicato a questo autore maggiore attenzione e che più di ogni altro ha
contributo a far conoscere la sua opera, fornendone inoltre delle
indispensabili chiavi di lettura – insiste dunque sul carattere “incendiario”
dei Canti del caos e il discorso si
può senz’altro estendere all’intero immaginario moreschiano. Non a caso, il
volume che contiene i due pamphlet anticalviniani s’intitola Il vulcano e Gli incendiati è il titolo di un suo recente romanzo (Moresco
2010); va sottolineata, inoltre, la forte presenza dell’immagine del fuoco, sia
nella sua narrativa che nella sua saggistica (nei casi in cui sia possibile
distinguere un genere dall’altro); e termini afferenti allo stesso campo
semantico popolano il suo linguaggio: in particolare, il verbo “esplodere” e
l’aggettivo “esploso” vantano un altissimo numero di occorrenze” (Beniamino Mirisola, Lezioni
di caos: Forme della leggerezza tra Calvino, Nietzsche e Moresco, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2015, p. 73).
[2] “Perché hai incendiato la costa?” ho provato a dirle,
perché avevo sempre in mente l’immagine del suo volto come l’avevo visto la
prima volta nel buio, illuminato dal bagliore del fuoco.
“Perché
volevo bruciare con te!” (Antonio Moresco,
Gli incendiati, Mondadori, Milano,
2010, p. 58).
[3] Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/avventura/
[4] Pasquale La
Forgia, Apocalissi nostrane: la critica
italiana e la tentazione della fine, in “Studi Novecenteschi”, Vol. 30, N.
66, p. 310.
[5] Ibid.
[6] Guido Ferraro,
Oltre l’idea di città, in La città come testo: Scritture e riscritture
urbane, a cura di Massimo Leone,
Aracne, Roma, 2008, p.216. (Corsivo mio).
[7] Massimo Leone,
Signatim: Profili di semiotica della
cultura, Aracne, Roma, 2015, p. 375.
[8] Ivi, p. 379.
[9] Ivi, p. 384.
(Corsivo mio)
[10] Ivi, p. 390 (Corsivo
mio)
[11] La forgia,
Apocalissi nostrane, cit., p. 337.
[12] Stefano Giovannuzzi,
Realismo e letteratura: dalla parte di Wu
Ming, in “Comparative Studies in Modernism”, n. 9, 2016, p. 48.
[13] Ibid.: “ In
questi termini, molto sinteticamente, ho riassunto la posizione teorica di Wu
Ming in New Italian Epic, ripresa poi
di recente anche in Utile per iscopo?,
di Wu Ming 2 (2014)”.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ivi, p. 51.
[17] Ibid.
[18] Wu Ming 1,
Breckenridge e il continuum, in Wu Ming, Giap!, a cura di Tommaso De
Lorenzis, Einaudi, Torino, 2003, p. 17. (Articolo pubblicato per la
prima volta su l’Unità, sabato 14
settembre 2002, sezione Orizzonti).