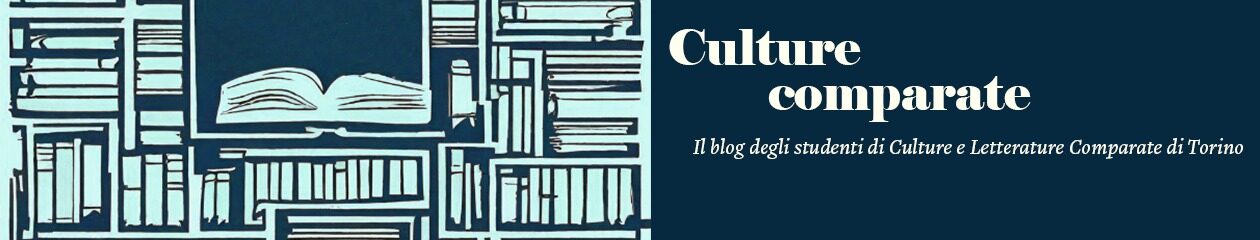di Samuele Campolo
Questa ‘lettura’ analizza il personaggio di Mar’ja Bolkonskaja, con particolare riferimento al suo rapporto con la fede religiosa, alle relazioni che instaura con gli altri personaggi e alla sua estraneità rispetto al fluire della storia.
☙
Fra i personaggi umani che animano Guerra e pace, Mar’ja Bolkonskaja occupa una posizione di secondo piano [1]. Come tutti i personaggi femminili, in primo luogo, è relegata fuori da un palcoscenico elettivo del romanzo, quello del campo di battaglia e delle relazioni diplomatiche, delle spedizioni militari e dell’azione politica: la scena della guerra. A questa estraneità necessaria, poi, se ne aggiunge un’altra: il suo spirito delicato e altruista, il carattere remissivo e l’abnegazione che la contraddistinguono la inducono a rinunciare anche al margine di iniziativa che le spetta e ne limitano l’azione e l’affermazione. Scopo di questo lavoro è descrivere il personaggio di Mar’ja, con particolare riguardo alla sua fede religiosa e alle conseguenze che essa comporta sul piano intellettuale e spirituale; si rifletterà inoltre sul rapporto fra il destino di questo personaggio e la grande storia e sulla ricerca personale condotta da Mar’ja verso il raggiungimento di una felicità terrena.
Centrale nella definizione di Mar’ja è, anzitutto, la sua devozione religiosa: l’azione in cui è occupata quando il lettore si imbatte per la prima volta in lei è la preghiera (I, I, 22); le risposte della religione guidano il suo cammino individuale e vengono suggerite a chi le si rivolga per un consiglio – si pensi alle parole con cui risponde al fratello Andrej dopo che questi le ha confessato di non amare sua moglie (I, I, 25). «Ah! si nous n’avions pas la religion pour nous consoler, la vie serait bien triste» (I, I, 22), esclama ancora la principessina in una lettera alla sua amica Julie rivelandole come, più che un riferimento morale, il suo affidamento a Dio rappresenti una fonte di consolazione per affrontare i dolori della vita. Devotissima, ma niente affatto irrigidita dalla fede nella sua sensibilità, Mar’ja è ben capace di interpretare l’altrui desiderio. Lo dimostra in una conversazione con Andrej a proposito di sua moglie Liza: «Che c’entra! Io non desidero un’altra vita, né posso desiderarla […] Ma tu pensa, André, per una donna giovane e di mondo seppellirsi negli anni migliori in campagna, da sola…» (I, I, 25). Allo stesso modo, di fronte all’umiliazione di cui è oggetto quando Anatole Kuragin, dopo avere simulato interesse nei suoi confronti, seduce la sua dama di compagnia e viene sorpreso con lei proprio dalla principessina, Mar’ja, lungi dal recriminare a mademoiselle Bourienne la sua sfrontatezza, farà un passo indietro e si augurerà che i due possano presto convolare a nozze: «la mia vocazione […] è essere felice di un’altra felicità, la felicità dell’amore e del sacrificio di sé» (I, III, 5).
Ma che conseguenze ha questa vocazione al sacrificio di sé nei suoi rapporti con gli altri personaggi e con la realtà, cioè nelle sue facoltà relazionali e intellettuali? In questo senso, Tolstoj è abile nel rappresentare una continua dialettica fra uno sguardo penetrante e rivelatore da una parte, e un’irriducibile ottusità dall’altra. Almeno due passaggi del romanzo illustrano in modo esemplare i limiti dell’intuito di Mar’ja. Il primo, collocato nella sequenza già richiamata sopra, è quello in cui la fanciulla incontra per la prima volta il principe Anatole, che le fa visita presso la tenuta di Lysye Gory insieme al padre Vasilij: «possibile che sia mio marito, proprio quest’uomo estraneo, bello, buono; soprattutto buono» (ibidem), si chiede la principessa dopo averlo conosciuto. Il principe Kuragin, però, è tutt’altro che buono, e Tolstoj mostra tutta l’inettitudine di Mar’ja a decifrare qualsiasi malizia nei comportamenti del ragazzo. Il secondo passaggio si trova nelle pagine in cui, in un’altra lettera indirizzata a Julie, Mar’ja tenta di dissuaderla dal prestare ascolto alle chiacchiere su un presunto fidanzamento di suo fratello Andrej con Nataša: «Io non penso che Andrej si sposerebbe mai con chicchessia, e in particolare con lei» (II, III, 25), dichiara con ferma sicurezza, esponendo così le sue convinzioni all’ironica sconfessione che i fatti le imporranno nel capitolo successivo. Tuttavia, in altre occasioni il cuore di Mar’ja sa nutrirsi di una speranza salvifica, e i suoi occhi «grandi, profondi e radiosi» (I, I, 22) sono davvero in grado di illuminare la bontà d’animo di chi le sta innanzi. Così, non si arrende allo sconforto quando, dopo il ferimento di Andrej ad Austerlitz, nessuna notizia sulle sue condizioni giunge a Lysye Gory – e la sua speranza sarà gratificata, mentre sarà smentito lo scetticismo amareggiato di suo padre Nikolaj (II, I, 7 e 8). Allo stesso modo Mar’ja dichiarerà senza riserve l’affetto che la lega a Pierre, del quale riconosce con perfetta intuizione la straordinaria bontà (II, II, 14 e II, V, 4).
Eroina spirituale e amorale, secondo le categorie proposte da Marie Sémon [2], concentrata sui bisogni e le mancanze dell’altro, a Mar’ja è altresì preclusa ogni possibilità di evoluzione. Rassegnata alla propria bruttezza, ancora verso la conclusione del secondo libro appare disincantata su ogni possibilità di sposarsi (II, V, 2): mentre le storie degli altri personaggi si sviluppano secondo direttrici impreviste, quella di Mar’ja rimane imprigionata nei confini austeri della sua famiglia di provenienza. Il suo rapporto emotivamente incestuoso con il padre, in particolare, le impedisce di costituirsi nei termini di una dialettica generazionale. Madrina del nipotino Cocò al suo battesimo, affianca proprio il suo vecchio padre che riveste il ruolo di padrino (II, I, 9), come una madre si prende cura del piccolo, aiutando suo fratello in luogo della defunta moglie (II, II, 8 e 9), e quando questi si fidanzerà con Nataša, lei si troverà costretta a reprimere un’intensa gelosia (II, V, 7). Sembra, insomma, che a Mar’ja manchi completamente un suo Bildungsroman. D’altra parte, come ha sottolineato Hayden White, lo sviluppo di tutti i personaggi in Guerra e pace è incompatibile con i canoni del romanzo di formazione occidentale, perché «è difficile credere che il loro cambiamento sia un’evoluzione. Tolstoj non sembra ammettere la possibilità di realizzare una potenzialità ricevuta alla nascita» [3]. Non tanto la mancanza di una Bildung lineare, allora, ma l’assenza di un’autentica metamorfosi costituisce la cifra di questo personaggio.
Una sola idea di ribellione si fa strada nella sua mente, in reazione alla fissità della sua esistenza: «diverse volte era stata sul punto di lasciare tutto e fuggire di casa. Nella sua immaginazione si vedeva già […] vestita di un rozzo saio, camminare con bastone e bisaccia sulla strada polverosa, dirigendo il suo pellegrinaggio senza invidia, senza amore umano, senza desideri, da un santo monastero all’altro» (II, III, 26). Ma Mar’ja non si unirà mai alla «gente di Dio», non si compirà nemmeno come jurodivyj: «ma poi, alla vista del padre e soprattutto del piccolo Cocò, sentiva il suo proposito vacillare […] e capiva di essere una peccatrice: amava il padre e il nipotino più di Dio» (ibidem). Considerata nel suo complesso, sembra che proprio in questa esitazione Mar’ja maturi la sua esperienza conoscitiva. La fede religiosa non si configura per lei come un punto d’approdo: essa non ha alcun valore euristico, né per gli altri, che ne riconoscono l’inadeguatezza, né per sé, perché non la inizia alla vita. Solo quando essa le si rivela nella sua insufficienza, infatti, Mar’ja si incammina sulla strada di una sua felicità terrena: così avviene nell’epilogo del romanzo, quando, dopo essersi finalmente sposata con Nikolaj, medita fra sé: «‘mai, mai avrei creduto che si potesse essere così felici’: ma nello stesso tempo sospirò, e una quieta tristezza si espresse nel suo sguardo profondo, come se oltre alla felicità che provava ci fosse un’altra felicità, irraggiungibile in questa vita, di cui senza volerlo si era ricordata in quel momento» (ep., I, 9).
«[I] personaggi umani [di Guerra e pace] tendono tutti […] a una felicità esplicitamente terrena, tranquillo e armonico appagamento delle esigenze insite nel temperamento di ognuno», ha scritto Leone Ginzburg . Qui egli postulava una distinzione fra i personaggi umani, il cui sguardo è rivolto alla dimensione privata, spontanea e creativa della vita, noncurante del fluire della storia, e i personaggi storici, calati nel loro tempo e illusi di orientarne il corso. Una tale dicotomia, non sempre accolta dalle interpretazioni successive [5], ha comunque il merito di presentare i personaggi d’invenzione di Guerra e pace nel loro ruolo di depositari di una verità umana profonda, da cui restano esclusi i protagonisti della storia. Se il caso e il genio muovono la storia, con il primo essa si fa beffe degli uomini, al secondo chiede di sacrificare il suo destino umano e individuale al proprio inarrestabile progresso. Né Pierre né Andrej, né tantomeno Nataša o Mar’ja, hanno a che fare con questo sacrificio: ciascuno di loro persegue una ricerca a cui Kutuzov e Napoleone non possono in nessun modo dedicarsi. Questi sono trascinati dalla storia nell’errata convinzione di guidarla, quelli si ripiegano sul loro destino e sono in grado di elaborarlo con sincera rassegnazione. Mar’ja Bolkonskaja, allora, rappresenta l’incarnazione più radicale di questo paradigma: rinchiusa entro l’orizzonte del focolare domestico, figlia femmina di un padre dispotico, vilipesa per la sua bruttezza, la principessa abbraccerà infine la sua felicità. Il meno volitivo dei personaggi del romanzo, in questa prospettiva, sembra ottenere qualcosa di più dello stesso Napoleone, perché sa desiderare in modo diverso, rinunciando al proposito di intervenire nella storia, in armonia con le leggi della vita.
Note
[1] Si adotta qui la categoria di personaggio umano nell’accezione in cui ne ha parlato Leone Ginzburg nella sua prefazione a Guerra e pace (GINZBURG 1942). Cfr. infra per l’approfondimento di questa nozione.
[2] Cfr. SÉMON 1986. Secondo la studiosa, le protagoniste positive delle storie di Tolstoj sono ispirate a un paradigma di amoralità. La difficoltà di Mar’ja nel formulare giudizi morali (sul seduttore Anatole, su suo fratello Andrej) si spiegherebbe allora con la sua distanza dalla logica che domina i personaggi maschili, fondata sul premio e sulla punizione: «le nozioni di equità e di giustizia non esistono ai [suoi] occhi» (ivi, p. 209, trad. mia).
[3] WHITE 2005, p. 233.
[4] GINZBURG 1942.
[5] «Tolstoj trasforma tutte le sue figure storiche in personaggi e fa l’opposto – o almeno ci prova – con i personaggi d’invenzione, che tenta quasi di trasformare in figure storiche» (WHITE 2005, p. 235), arriva a scrivere Hayden White. Si osservi peraltro come la sua riflessione sia tutta intesa a decostruire le apparenti dicotomie individuabili nel romanzo (guerra e pace, personaggi storici e personaggi umani, agire e patire).
Bibliografia primaria
L. TOLSTOJ, Guerra e pace, trad. di Emanuela Guercetti, Einaudi, Torino 2019.
Bibliografia critica
GINZBURG 1942 = L. GINZBURG, prefazione a L. TOLSTOJ, Guerra e pace, trad. di Enrichetta Carafa d’Andria, Einaudi, Torino 1942, ripubblicata in L. TOLSTOJ, Guerra e pace, trad. di Emanuela Guercetti, Einaudi, Torino 2019.
SÉMON 1982 = M. SÉMON, La vie spirituelle des héroïnes tolstoïennes, in «Revue des études slaves», LIV (1982), pp. 205-214.
WHITE 2005 = H. WHITE, Contro il realismo storico, in F. MORETTI, P.V. MENGALDO, E. FRANCO (a c. di), Il romanzo, Einaudi, Torino 2001-2003, vol. V, pp. 221-237.